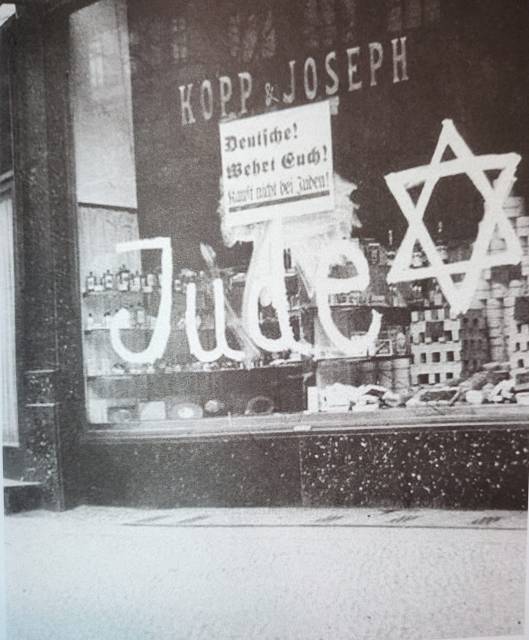“Si viaggia per meandri bui, per vie tortuose
che non conducono mai dove ti aspetteresti”
Primo Levi
Ogni epoca ha coltivato le sue paure, come semi destinati a germogliare nel terreno instabile delle civiltà che la attraversano. Dall’assedio di guerre e carestie agli incubi medievali di pestilenze e dannazione eterna, fino all’agghiacciante vuoto dell’era moderna, l’umanità si è sempre trovata a danzare sull’orlo dell’angoscia. E se oggi il tormento non fosse più legato alla sopravvivenza fisica, ma piuttosto all’inutile rincorsa di un senso?

Kafka, cronista impietoso del disagio esistenziale, ci trascina nei margini oscuri delle nostre paure: mutarci in creature disumane, perderci nelle maglie di un arresto senza causa, o svuotare di significato ogni gerarchia sociale che ci circonda. A cento anni dalla morte di Franz Kafka, la voce visionaria che ha trasformato l’angoscia in poesia e l’assurdo in un implacabile specchio dell’esistenza umana continua a inquietare e affascinare. Spesso definito il “cronista dell’assurdo” o il “poeta del moderno incubo”, Kafka rimane un enigma letterario di rara intensità. I suoi testi, solcati da un’alchimia di potere e umiliazione, vibrano ancora oggi come un grido oscuro che risale dai recessi più profondi dell’anima. L’intreccio complesso tra potere e condizione umana ha affascinato studiosi e critici per generazioni, dando vita a un fervido dibattito che continua a crescere. Tra le voci più brillanti spicca Elias Canetti, capace di esplorare con acume le profondità delle dinamiche di sottomissione e umiliazione, rivelando le oscure trame che legano l’individuo al dominio. Attraverso una lettura che intreccia riflessione filosofica e osservazione psicologica, Canetti mette in luce l’intreccio di forza e fragilità che permea i personaggi kafkiani, piegati sotto il peso di autorità opprimenti e gerarchie inscalfibili. Questa analisi puntuale non solo offre un’interpretazione profonda dell’opera di Kafka, ma rispecchia altresì i meccanismi universali che definiscono le dinamiche del potere nella società moderna, poteri invisibili e inaccessibili. Nel racconto La Metamorfosi, la famiglia si configura come l’ambiente centrale in cui si manifesta questo dominio oppressivo, dando vita a un autentico trionfo del disamore. La metamorfosi del protagonista Gregor in insetto rappresenta sia una conseguenza, chiaramente metaforica, di quel profondo senso di inferiorità provato come figlio, sia una via di fuga, per quanto paradossale possa sembrare, dall’autorità esercitata su di lui. Da questa prospettiva, emergono con particolare rilievo i momenti del romanzo in cui il coleottero Gregor tenta, almeno in modo simbolico, di resistere al potere coercitivo esercitato dalla famiglia. Un esempio significativo si trova nel brano Un amore di carta, dove Gregor cerca di proteggere il ritratto fotografico di una diva, appeso alla parete della sua stanza, dall’azione metodica della sorella e della madre. “E ora cosa prendiamo?” disse Grete guardandosi intorno; e il suo sguardo incontrò quello di Gregorio sulla parete. Se conservò il sangue freddo, fu per la mamma. Tremando tutta, e cercando di coprire con la testa la vista del muro, disse alla donna: “Vieni, forse è meglio che torniamo un momento in sala”. Gregorio capì che Grete voleva mettere al sicuro la mamma per poi cacciarlo dal muro. Ci si provasse! Lui non si sarebbe mosso dal suo quadro: piuttosto le sarebbe saltato in faccia”. Un aspetto rilevante di questo processo è che, all’interno della famiglia, nessuno conversa più con Gregor, e ciò è avvenuto precisamente da quando ha perso la capacità di esprimersi verbalmente. Come spesso accade, anche nei contesti più articolati dell’ordine sociale, le dinamiche di esclusione si manifestano attraverso il silenzio e l’indifferenza, trasformati in comportamenti sistematici e pratiche percepite come normali. Elias Canetti, nei suoi studi e nei suoi scritti su Kafka, evidenzia come la metamorfosi non rappresenti soltanto un processo simbolico o psicologico, ma sia profondamente connessa al corpo che ne è coinvolto. Nel testo L’altro processo. Le lettere di Kafka a Felice* (1968), Canetti mette in luce come, nella Metamorfosi di Kafka, l’umiliazione, il dolore e l’isolamento del protagonista trovino espressione diretta nel suo corpo. Fin dall’inizio della narrazione, il corpo diventa il fulcro concreto e opprimente della trasformazione. Di conseguenza, il figlio si ritrova inevitabilmente sottomesso a un processo di mortificazione, mentre l’intera famiglia appare attivamente coinvolta nel sostenerlo. L’umiliazione, inizialmente inflitta con una certa esitazione, si intensifica man mano che le circostanze la favoriscono. Gradualmente, tutti i membri della famiglia, quasi senza difese e contro la loro volontà, finiscono per parteciparvi. Il gesto iniziale viene ripetuto ancora e ancora: è infatti attraverso l’agire della sua famiglia che Gregor Samsa, il figlio, subisce pienamente e in modo irreversibile la trasformazione in insetto. All’interno del contesto sociale in cui vive, tale metamorfosi lo condanna ulteriormente a diventare un parassita.

Nel breve testo di Tommaso Landolfi [1]intitolato Il babbo di Kafka, contenuto nella raccolta La spada, sembra manifestarsi il meccanismo psicologico che probabilmente ha ispirato il racconto kafkiano, ossia il complesso e tormentato rapporto con la figura paterna. Tuttavia, in questo caso, il testo dell’autore boemo subisce un ribaltamento. Se nell’opera originale il mostro rappresentava una sorta di proiezione di Kafka, schiacciato dal peso del legame conflittuale con il padre, qui è invece il padre stesso a incarnare quella figura mostruosa. Il padre-mostro viene descritto con un’espressione disgustata, tipica dei momenti in cui si abbandonava a esasperanti rimproveri diretti verso il figlio. Nemmeno l’uccisione finale del terrificante ragno riuscirà a risolvere definitivamente la situazione: Kafka credeva di essersene liberato, ma era solo un’illusione; gli restavano ancora molti altri ragni da affrontare. L’orrore evocato dalla figura del mostro, inspiegabile nella narrazione kafkiana, in questa versione appare illuminato sotto una luce sinistra, amplificata da un ulteriore senso di raccapriccio e profonda inquietudine. Tra i romanzi di Kafka, Il Processo[2] è senz’altro quello che ha meglio contribuito a diffondere nel mondo l’immagine di un’esistenza impregnata di mistero e oppressione, definita comunemente come “kafkiana”. Sin dalle prime pagine, l’opera mette in contrasto due dimensioni dell’esperienza umana che risultano inconciliabili: da una parte, la vita quotidiana ordinaria, dove Joseph K. si presenta come un rispettabile funzionario di banca immerso in un contesto regolato da razionalità e norme giuridiche; dall’altra, l’enigmatico e inquietante universo del tribunale, governato da una logica punitiva arbitraria e implacabile. Il protagonista si ritrova intrappolato in una spirale di disperazione, costretto a cercare di difendere la propria innocenza con la logica, pur sapendo che non potrà mai provarla. L’accusa che lo schiaccia non riguarda un crimine commesso, bensì il fatto di non conoscere la legge e di non riconoscere l’autorità del tribunale che la incarna. È un’accusa tanto sfuggente quanto implacabile, che lo conduce inesorabilmente al tragico epilogo: la sua esecuzione. Nel capitolo IX “Nel duomo” [3]

il sacerdote legato al tribunale racconta a K. una parabola di tono biblico, ormai divenuta celebre, che riporto di seguito: «Non illuderti, – disse il sacerdote. «In che cosa dovrei illudermi?» chiese K. -Ti illudi sul tribunale», disse il sacerdote, «negli Scritti che preludono alla Legge, di questa illusione si dice così: Davanti alla porta della Legge c’è un guardiano. Un uomo di campagna viene da questo guardiano e gli chiede di poter entrare nella legge. Il portiere però gli dice che ora non può permettergli di entrare. L’uomo riflette e poi chiede se allora potrà entrare più tardi. “Può darsi”, dice il guardiano, “ora però no”. Siccome la porta che dà accesso alla legge è aperta come sempre e il guardiano si sposta da un lato, l’uomo si curva per guardare, attraverso la porta, all’interno. Quando il guardiano se ne accorge, ride e dice: “Se ti attira tanto, cerca pure di entrare malgrado il mio divieto. Sta’ attento però: io sono potente… Alla fine la sua vista si indebolisce e non sa se davvero intorno a lui si sta facendo più buio o se sono solo i suoi occhi che lo ingannano. Nel buio però ora distingue un bagliore che riluce ininterrotto attraverso la porta della Legge. Non gli resta più molto da vivere. Prima della morte tutte le esperienze di tutto quel tempo gli si riassumono nella testa in una domanda, che ancora non ha fatto al guardiano. Gli fa un cenno, perché non può più sollevare il suo corpo che si sta irrigidendo. Il guardiano deve chinarsi profondamente fino a lui, perché la differenza di statura è molto cambiata a sfavore dell’uomo. “Cosa vuoi sapere ancora”, chiede il guardiano, “sei insaziabile”. “Tutti desiderano la legge”, dice l’uomo, “come mai allora in tanti anni nessuno tranne me ha chiesto di entrare?” Il guardiano si rende conto che l’uomo ormai è alla fine, e per raggiungere ancora il suo udito che sta svanendo gli grida: “Da qui non poteva essere ammesso nessun altro, perché questo ingresso era riservato solo a te. Ora vado e lo chiudo”».
Nel cuore di ogni uomo si nasconde una porta, una soglia che conduce alla verità, alla legge, a ciò che ognuno cerca e teme. La narrazione del sacerdote è un labirinto di simboli, un enigma avvolto nell’ombra, ma nel suo centro pulsa una riflessione antica e sempre attuale: l’illusione del controllo e il mistero dell’accesso al sapere. L’uomo, con la sua domanda impaziente, si pone davanti alla porta come un peregrino smarrito; la Legge, inespugnabile e sublime, resta lì, silenziosa e distante. E il guardiano? Lui è il custode ambiguo, al contempo ostacolo e guida, che lascia intravedere ma non attraversare. Non è forse questa la metafora della vita? Un incessante tentativo di afferrare qualcosa che sembra sempre sfuggire, nonostante sia lì, davanti a noi? E quel “bagliore ininterrotto” che illumina attraverso il buio? Ci provoca, ci infiamma l’anima: è speranza o scherno? È forse il senso stesso del cammino umano? Ogni passo verso la conoscenza intreccia desiderio e frustrazione, una battaglia tra i limiti che ci contengono e la volontà di superarli. Nel finale, amaro nel testo, si svela l’ultima beffa: quella porta era unica, esclusiva per quell’uomo, riservata a un momento irripetibile che mai fu colto. Come un segreto profondo che si schiude solo nel barlume dell’ultimo respiro. Il guardiano chiude la porta e va oltre, portando con sé una verità che forse non aveva mai avuto voce. Ogni lettore è come quell’uomo di campagna. Ci avviciniamo alle nostre porte personali con dubbi, paura e coraggio al tempo stesso. Ma se c’è un messaggio nascosto in questa parabola inquietante, forse è che non basta desiderare l’accesso: bisogna chiederlo davvero. O forse non chiederlo affatto e semplicemente osare attraversare. Tre elementi fondamentali delineano la complessità del testo: la Legge che emana un bagliore perpetuo oltre la soglia, quasi mistico nella sua intangibilità; l’uomo della campagna, che ingenuamente immagina la Legge come qualcosa di universale e sempre accessibile; e il guardiano, figura paradossale che incarna l’ambiguità—negando l’accesso con decisione, per poi rivelare che quella porta era unica e dedicata esclusivamente all’uomo stesso. Questa combinazione di contrasti e paradossi lascia spazio a una riflessione disorientante e penetrante: la Legge appare eterna e onnipresente, ma inaccessibile; il contadino rappresenta l’inesauribile desiderio di ottenere ciò che si percepisce come diritto naturale; il guardiano diventa simbolo enigmatico di un potere oscuro, crudele, e forse insensato. [4]Il significato ultimo rimane elusivo, sfuggendo a qualsiasi interpretazione definitiva. Kafka, con il suo genio provocatorio, sembra costruire una macchina narrativa che intrappola il lettore in cerchi di dubbi. Chi è il guardiano? È davvero una figura esterna o rappresenta piuttosto il nostro personale sabotatore, quella voce interiore che ci blocca davanti a opportunità uniche, ricordandoci brutalmente il peso dell’incertezza? La scena si trasforma così in uno specchio di esistenza in cui il fallimento di comprendere pienamente non è un errore, ma un’essenza stessa della condizione umana. La lettura de Il Processo, un libro intriso di malinconia e poesia, lascia un segno indelebile: si diventa più tristi, ma anche più consapevoli. Così è, sembra suggerire il racconto, questo è il destino umano; si può essere accusati e puniti per una colpa mai commessa, una colpa sconosciuta che il “tribunale” non rivelerà mai. Eppure, di questa colpa si può provare vergogna, portandola con sé fino alla morte, e forse persino oltre. Tradurre, tuttavia, è qualcosa di più che leggere: uscire da questa traduzione è stato come uscire da una malattia. Così scrive Primo Levi nella nota del traduttore.La tragedia che emerge dai grandi testi di Kafka[5] è il riflesso di un’umanità che si trova imprigionata tra le mura invisibili di un senso che si è sgretolato, lasciando solo frammenti sparsi di razionalità. Ma ciò che rende questa tragedia tanto universale e potente non è solo la scoperta dell’assurdo: è l’irriducibile ostinazione degli esseri umani nel cercare un significato anche dove non esiste. È come aggrapparsi a una corda sospesa su un abisso, pur sapendo che sotto non c’è alcuna rete a salvarci, né alcuna promessa di salvezza. Il senso dell’esistenza è una luce fioca all’orizzonte: intangibile, inafferrabile. Una verità che non può essere svelata, ma che ci condanna inevitabilmente a inseguirla senza tregua. [6]Gli eroi kafkiani si trasformano così in specchi deformanti della nostra stessa condizione: vogliono comprendere, vogliono un perché, ma ottengono solo silenzi o risposte enigmatiche che scavano ulteriormente nella loro angoscia. In questo persistente desiderio di dare ordine al caos si nasconde, paradossalmente, l’elemento più profondamente umano: l’incapacità di accettare il vuoto, la disperazione che si fa spinta vitale. Forse è proprio qui la provocazione più alta della tragedia kafkiana. Non sta solo nella resa all’assurdo, ma nella consapevolezza che è la nostra continua ricerca del senso a creare un conflitto inesauribile. Se smettessimo di interrogarci, se accettassimo il nulla senza opporci, finiremmo forse per liberarci? Oppure, al contrario, cadremmo in uno stato più tremendo, quello dell’apatia totale? Kafka non ci offre risposte definitive; lascia a ognuno di noi il compito di convivere con queste domande aperte. E in fondo, non è forse questo stesso enigma a essere il motore della nostra esistenza?
Maria Allo
[1] Giorgio Luti/ I diversi piani della poetica di Landolfi, (in Letteratura italiana del ‘900, Vol.VI Marzorati, Milano 1979) p.496
[2] Scrittori tradotti da Scrittori Vol.1, IL PROCESSO di Frank Kafka nella traduzione di Primo Levi
[3] Scrittori tradotti da Scrittori Vol.1, IL PROCESSO di Frank Kafka nella traduzione di Primo Levi, Cap. IX pp.233-234
[4] P. Citati, Kafka, Rizzoli, Milano 1987
[5] Franz Kafka , il suo tempo , la sua opera , Mondadori, Scrittori del Novecento
[6] G. Baioni, Kafka, Romanzo e parabola, Feltrinelli, Milano 1972.