
Ilaria era la seconda delle tre sorelle Pastrone. Marta, la prima, s’era sposata appena ventenne, era andata in moglie a un giovane di belle speranze e molta ambizione, un propellente che lo rendeva arroccato a un rigido orgoglio di sé. Pessima dote da portare ai Pastrone, buona per un rigetto come un trapianto malriuscito, e per quanto Marta s’impegnasse a irrorare i rapporti di ciclosporina, cortisone e interferone, i rimedi avevano scarso successo. Agnese, la minore, era predestinata a raccogliere l’eredità dell’impresa familiare. Un negozio di abbigliamento messo su e ben avviato dai genitori, al punto d’essere la boutique più rinomata di Sanfilocco, in provincia di Gìtania. Agnese, dopo tanti anni di lavoro come dipendente, rilevò l’attività commerciale dalla madre, il padre era morto qualche anno prima. Lo fece obtorto collo, perché così era stato deciso, un destino già scritto verso il quale non ebbe volontà e ribellione sufficienti a opporsi, per quanto in cuor suo avrebbe preferito un’altra strada. Aveva frequentato la scuola d’arte e un lavoro creativo forse l’avrebbe attratta maggiormente, ma in certe faccende non pesano tanto i soldi e nemmeno il desiderio o l’entusiasmo, pressa il non vedere sbocchi o alternative migliori, l’essere consapevoli del rischio e dello spreco di demolire quanto già costruito in tanti anni di lavoro familiare: avviamento, credibilità, azienda, clienti, contatti, fornitori e benessere. Tutto ciò che significa impresa. Agnese diventò perciò imprenditrice per investitura familiare, senza particolare vocazione. Ilaria Pastrone, la seconda figlia, stava nel mezzo in ogni senso, non aveva talenti manifesti, piuttosto difetti, sapeva scrivere, ma non guidare, le piaceva mangiare bene, ma non cucinare, aveva un altro concetto di sé, ma difettava di determinazione. Aveva preferito studiare invece di lavorare nel negozio. Avere a che fare con una pluralità mutevole di clienti, percepiti come estranei, non l’attirava. Proprio per la sua scarsa inclinazione al commercio i genitori l’avevano esclusa dalla gestione dell’attività. Alla fine degli anni settanta l’unico desiderio che Ilaria riuscì a focalizzare con una qualche convinzione, era di allontanarsi da casa, dai genitori che percepiva come opprimenti e da una storia d’amore naufragata. Davide, il suo ragazzo fin dai tempi del liceo, dopo sei anni di fidanzamento, l’aveva tradita e lasciata per la sua migliore amica. Una vicenda talmente banale da essere penosa. Ilaria infatti non ne parlava mai, sentendosi nel raccontarla allo stesso tempo stupida e patetica. La delusione subita la segnò a tal punto che Ilaria non si innamorò più, non si sposò e non ebbe figli. Fu come se l’aspetto sentimentale dell’esistenza fosse definitivamente morto, sepolto da quell’episodio devastante. Del resto innamorarsi veramente è un’alchimia che ha del magico, accade poche volte nella vita per circostanze che si combinano tra loro in modo speciale. L’incontro, il bisogno, l’attenzione concorrono e si intrecciano con le stimmate della fatalità e spesso la sensazione che si avverte è che non poteva essere altrimenti, quasi operasse una forza cosmica potente e misteriosa, non tanto munita di frecce e calzari alati, ma piuttosto serpeggiante di vibrazioni. Può succedere all’opposto che il tempo trascorra e nulla accada, nessun fremito o segnale. Tutto dorme o tace. C’è altro a cui pensare.
Era il 1978 quando Ilaria decise di partire per Milano. C’erano già lì due cari cugini Carlo e Luigi con le loro famiglie impiantati nel hinterland, uno a Cusano Milanino, l’altro a San Donato Milanese. Essi costituirono una buona base d’appoggio per cercare alloggio e per trovare un lavoro. Ilaria trovò entrambi, il primo in via Torre di Guardia, 14 al centro di Milano, in una casa di ringhiera e l’altro presso un’importante azienda di telecomunicazioni. Quest’ultimo divenne il lavoro di tutta una vita fino al suo pensionamento. Di case invece Ilaria ne cambiò diverse, fino a sistemarsi in ultimo in una bella casa nuova e propria appena fuori Milano. Ilaria tornava spesso al Sud, alla casa d’origine specie al principio della sua permanenza in Lombardia. Le mancavano la famiglia, il cielo, il sole, il mare. La famiglia perché a distanza i rapporti conflittuali coi genitori s’erano dissolti, mentre le sorelle, essendosi sposate, l’avevano resa zia e lei adorava i suoi nipoti. Ilaria attraversava tutta la penisola almeno una volta all’anno, in estate, per andarli a trovare e con loro ritrovare quel clima solare e limpido che caratterizzava la Sicilia, la sua isola, del tutto diverso dall’aria nebbiosa e carica di smog della città metropolitana. Quando partiva aveva la valigia piena di regali per i nipoti. Una valigia ben diversa da quella di cartone verde legata con la corda del suo primo viaggio da emigrante. Questa appena comprata era morbida e leggera in similpelle color tabacco di ottima qualità, colma di doni: abiti, giochi, immancabili pigiami e un bel costume arancione comprato per sé alla Rinascente da sfoggiare sulle spiagge della Sicilia orientale. Ilaria affrontava un viaggio lunghissimo che la portava dalla città lombarda a Sanfilocco e al ritorno viceversa. Era un viaggio estenuante, ma interessante che la rapportava alla molta e varia umanità dei compagni di viaggio, anche se la sua natura schiva non ne traeva particolare piacere. Per molti anni Ilaria affrontò il lungo viaggio in treno, ciò fino a quando l’aereo non diventò il mezzo consueto per tratte così lunghe. Il cambiamento avvenne col ribaltamento del rapporto di convenienza tra aereo e treno, ma questo non accadde subito, solo molti anni più tardi, dopo l’ingresso nel nuovo secolo. A quel punto però la spinta a viaggiare di Ilaria s’era attenuata, giunse poi a scomparire del tutto col passare del tempo e l’avanzare dell’età. Ormai a Sanfilocco, sorelle e nipoti avevano dimensionato la propria vita al progetto scelto, ai propri desideri, i genitori erano morti, si formavano nuove famiglie, nascevano i pronipoti. Restavano solo nei ricordi i lunghi viaggi compiuti col treno che negli anni settanta e dintorni erano una specie di atto eroico. I treni erano stipati di emigranti che tornavano alle loro case in vacanza. Chi in Sicilia, chi in Calabria o Campania e alle altre regioni meridionali. La misura dell’affollamento del treno era testimoniata dai viaggiatori che, ultimi arrivati, non avendo trovato posto, sostenevano il viaggio seduti su sedili retrattili a molla distribuiti lungo i corridoi, retrattili perché i sedili scattavano verso l’incavo della parete dove erano alloggiati non appena cessava il peso che li teneva aperti. Chi compiva il viaggio in questa modalità doveva alzarsi in piedi ogni volta che qualcuno intendeva passare nei corridoi per recarsi ai servizi o scendere alla stazione successiva. Il passeggero ciondolava scomodo e sonnacchioso per tutto il resto del tempo. Erano necessarie ventiquattr’ore per percorrere oltre millecinquecento chilometri di ferrovia. Alla fine del viaggio i wc erano impraticabili. I cestini traboccanti di carta igienica sporca e cartacce, bucce di banana e arance. Il pavimento era sudicio e infangato, nauseante l’olezzo dell’urina. (segue)



ph. Loredana Semantica (scorci di ferrovia nella tratta Catania Siracusa)


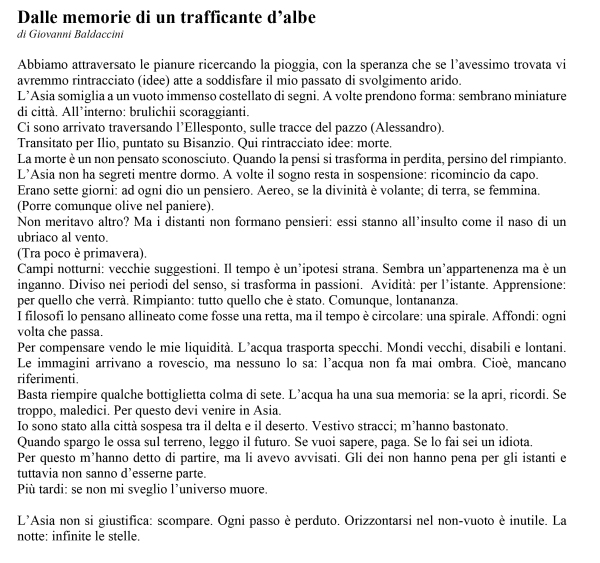
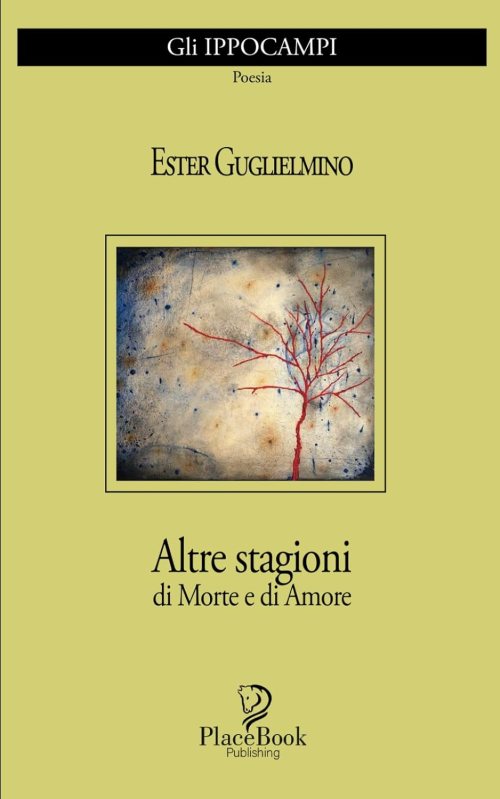
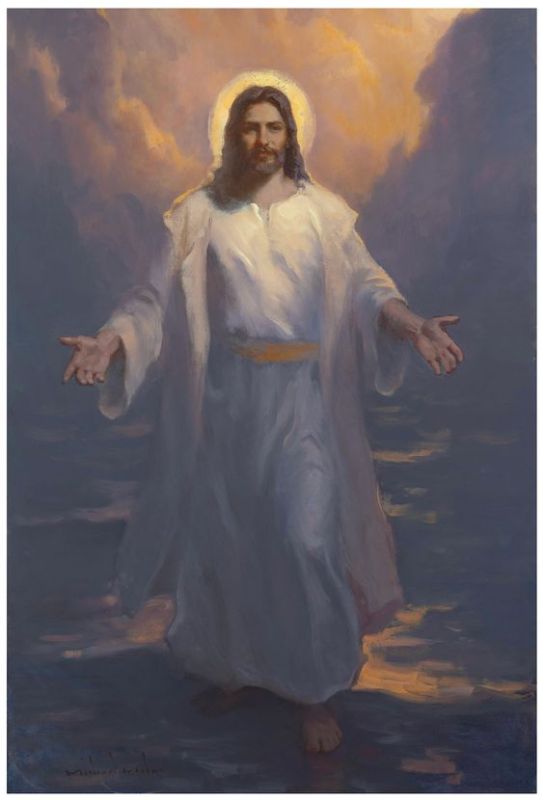

























Devi effettuare l'accesso per postare un commento.