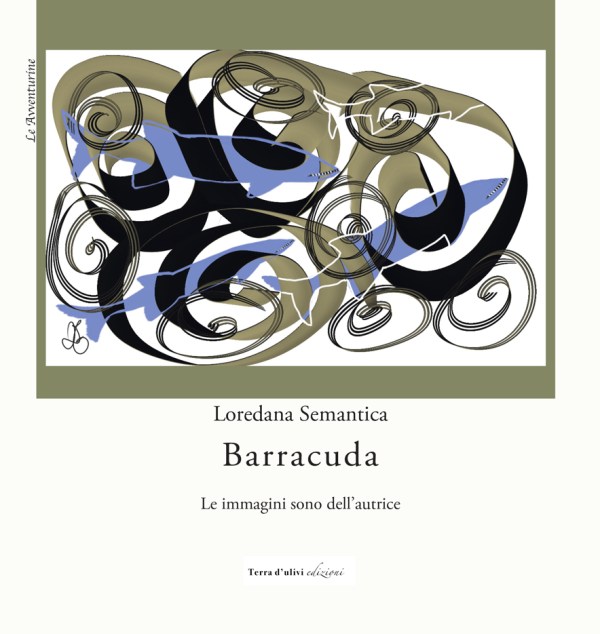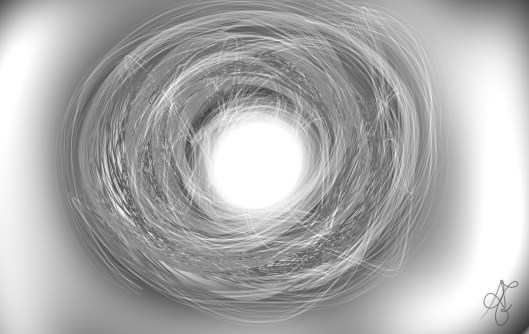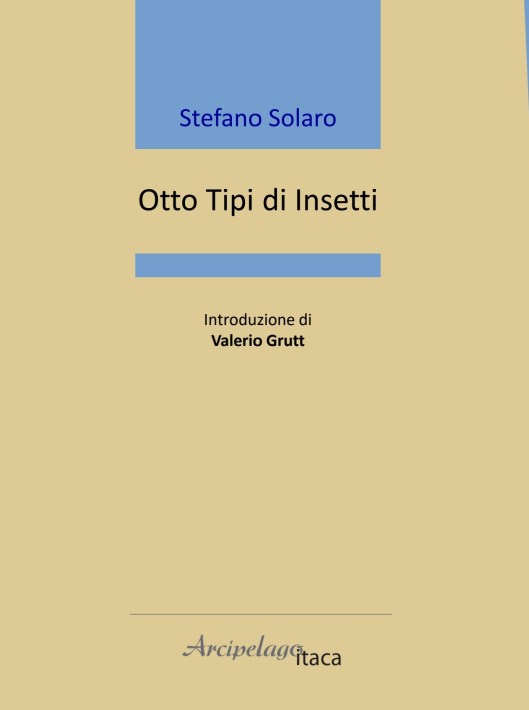Chiunque abbia avuto la possibilità e il privilegio di avere un cane conosce il suo amore e la sua dedizione incondizionata ma la storia di Hachiko, il cane divenuto un emblema di lealtà per il suo padrone, ha qualcosa di eccezionale, tanto da essere raccontata in film, serie televisive e videogiochi fin dalla sua morte, avvenuta nel 1935. Il nome della regione di Akita, nell’isola di Honshu, la più grande del Giappone, identifica anche la razza canina originaria della zona: cani dal pelo lungo, bianco o fulvo, utilizzati da cacciatori e samurai per la caccia e per l’arte della guerra, grazie al loro coraggio. Il professor Hidesaburo Ueno, ingegnere agronomo dell’Università di Tokyo, all’inizio titubante, decise di adottare il cucciolo perché mosso a compassione, data la presenza di una malformazione alle zampe anteriori, che si presentavano incurvate come se rappresentassero il numero otto in giapponese. Per questo motivo, il professor Ueno decise di chiamarlo Hachiko. Ogni mattina il professore prendeva il treno dalla stazione centrale di Shibuya a Tokyo, per recarsi al lavoro all’Università. Il suo cane Hachiko lo accompagnava ogni giorno fino al binario. Nel pomeriggio, al ritorno dalle lezioni, Hachiko era sempre lì ad attendere il suo padrone all’ingresso della stazione. Questa routine continuò per circa un anno, fino a quando, in un giorno di maggio del 1925, il professor Hidesaburo Ueno fu colpito da un’emorragia cerebrale mentre teneva una lezione all’Università. Morì sul colpo e non fece mai ritorno sul treno che Hachiko continuava ad aspettare a Shibuya. Nonostante ciò, il cane rimase fedelmente davanti alla stazione. La sua presenza non passò inosservata: i commercianti, gli impiegati, i viaggiatori di Shibuya iniziarono a prendersi cura di lui mentre la sua storia si diffondeva in tutta Tokyo. Gli anni trascorsero e nel 1934, dopo nove anni di attesa, le autorità di Shibuya decisero di dedicargli una statua di bronzo proprio nel luogo in cui il cane continuava a sperare nel ritorno del professor Ueno. Un anno più tardi, Hachiko morì a causa dell’età avanzata ma è ancora oggi ricordato come esempio di amore e lealtà di un cane nei confronti del suo padrone. Il brano racconta l’ultimo giorno di vita di Hachiko alla stazione.
*
I veterinari giapponesi ritengono che la vita di un cane di razza akita abbia una durata di circa dieci anni. Hachiko ne aveva undici e qualche mese. Dieci dei quali trascorsi in attesa del professor Eisaburo Ueno, perché questi gli aveva promesso che si sarebbero incontrati alla stazione di Shibuya e lui lo aspettava là per una semplicissima ragione: che il professore gliel’aveva promesso. La sera dell’otto marzo, Hachiko era sotto un vecchio vagone. Il freddo era pungente e gli penetrava nel cuore. Le gambe gli tremavano, ma ciò nonostante lui si alzò e andò verso la stazione. Avanzó lentamente nelle strade di Shibuya, un percorso che conosceva a memoria perché l’aveva fatto esattamente tremila cinquecento tredici volte- o, che è lo stesso, dieci anni – sotto la neve di febbraio, i venti di novembre o le piogge di aprile. Cosa sono dieci anni di freddo, fame, sete, delusioni, disperazione e frustrazione? Niente. Niente se, come quella sera, Hachiko aveva la certezza di rivedere il professor Ueno. Perciò, per quanto quella sera, già piuttosto scura, nevicasse e ci fosse un freddo pungente, Hachiko si mise davanti alla porta della stazione di Shibuya, come ogni giorno. Ibuki e il capostazione lo videro arrivare e si dissero:
– É giù. Non ci vede più da un occhio.
– Poveretto – aggiunse il signor Sato, il capostazione. – Non credo che passerà questa notte.
Ibuki gli si avvicinò, gli accarezzò la testa e tentò di tirarlo nel deposito dove finalmente godeva della stufa tanto desiderata. Ma Hachiko resistette, piantando le zampe al suolo. Chi avesse voluto spostarlo, avrebbe avuto bisogno di una ruspa. Quel giorno Hachiko abbaiò a quasi tutti quelli che lo salutarono, come per accomiatarsi. Gli ultimi a lasciare la stazione, dopo che la signora Shuto aveva raccolto le sue cose, furono Ibuki e il capostazione Sato, e quest’ultimo lo guardò come se fosse l’ultima volta che lo vedeva dopo dieci anni che condividevano tante serate di attesa. A mezzanotte, la neve incominciò ad ammucchiarsi intorno a lui, ma Hachiko rimase disteso davanti alla porta. Il silenzio che accompagna la solitudine era tagliato da un vento affilato come un coltello, che gli penetrava nel petto magro come un ago da sarta. Aveva gli occhi mezzi chiusi perché le raffiche di neve gli impedivano di vedere la porta, ma stava li, nel caso quella fosse la sera scelta dal professore per ritornare. Aveva il naso ghiacciato e tremava. Era l’unico a non saperlo, ma la sua vita stava finendo, come una candela o come un bastoncino d’incenso che ha profumato il tempio e del quale restano solo le ceneri. A un tratto, fra la nebbia invernale che avvolgeva i binari, sentì un fischio lontano. Era di una locomotiva che avanzava lentamente in mezzo alla neve. Una cosa strana, perché l’ultimo treno era arrivato a Shibuya più di tre ore prima e alla stazione non c’era più nessuno, neanche il capostazione Sato, né la signora Shuto, né Ibuki, che se n’era andato a casa maledicendo il freddo. Hachiko tentò di alzare un orecchio, ma il cuore gli batteva appena. La vita che ancora gli restava fuggiva al ritmo del treno che entrava in stazione sferragliando. Ma quello era un treno come mai se n’erano visti a Shibuya, perché era bianco e dorato. La locomotiva sembrava d’oro, i finestrini erano talmente luminosi da abbagliare e se qualcuno l’avesse visto avrebbe detto che le sue ruote erano fatte di cristallo. Neanche Hachiko lo vide, perché aveva già chiuso gli occhi per non aprirli mai più. Per qualche secondo non accadde nulla. Solo si sentirono i fischi del vapore che sfuggiva dalla locomotiva mentre frenava sul binario. Sembrava che da quel treno non fosse sceso nessuno, ma poi le nubi e la nebbia si dissolsero e si vide che il cielo era pieno di stelle, come macchioline sospese, azzurre e bianche. Nel preciso momento in cui Hachiko chiudeva gli occhi per non aprirli mai più, la porta della stazione si apri lentamente e un bastone col puntale d’argento incominciò a battere sul selciato.
– Sei ancora qui, Hachiko? – gli sorrise il nuovo arrivato. – Me lo aspettavo. Bravo. Mi dispiace che tu abbia dovuto aspettarmi un po’ più del solito, oggi, ma ho perso il treno.
Hachiko aprì gli occhi e non credette a ciò che aveva davanti. Aveva aspettato dieci anni per ritrovarsi con lui, ma finalmente era lì, alla stazione. Il professor Eisaburo Ueno, Hachiko lo sapeva già, non si era dimenticato di lui. Ed eccolo lì, appena sceso da quel treno che aspettava da dieci anni. Hachiko tentò di guaire, ma non osò emettere alcun suono quando sentì una mano familiare che gli accarezzava il pelo.
– Su, andiamo – sussurrò il professor Ueno. Oggi sì che potrai accompagnarmi e salire sul treno. Ti avevo promesso che un giorno l’avresti preso, ricordi? E le promesse solenni si mantengono.
Hachiko si alzò tremando e lo seguì, incollato ai suoi pantaloni.
Entrambi salirono passo passo gli scalini della vecchia stazione di Shibuya, arrivarono sulla banchina e allora Hachiko vide per la prima volta il treno. Ma prima di salire, il professore si volse un attimo, perché da una casa vicina gli giunse la voce chiara, limpida e vibrante di una geisha che cantava una canzone popolare:
I fiocchi di neve cadono lentamente.
Cadono senza fine e si accumulano.
Tutte le montagne e i campi sono coperti
da candidi batuffoli di cotone.
– Senti la canzone, Hachiko? È la signora Sasaki. Canta ancora molto bene. No, non fermarti qui. Oggi vieni con me. Ricordi che un giorno ti ho promesso che saremmo tornati al mare? Quel giorno è arrivato. Era una promessa solenne, e queste non si rompono. Mai.
Hachiko guardò il padrone e con un saltello sali sul vagone dorato e si acciambellò in braccio a lui come aveva fatto quando aveva pochi mesi, e un’altra volta sentì il calore delle sue mani sul dorso. Ebbe paura per un attimo, perché quello era il primo ricordo che aveva del professore, un ricordo che veniva da un’epoca incerta, ma cosa importava? Il calore lo riempiva di nuovo da dentro. Il professore sorrise e Hachiko si addormentò all’istante mentre quelle mani lo accarezzavano.
Lluís Prats Martinez, Hachiko. Il cane che aspettava, Albe Edizioni