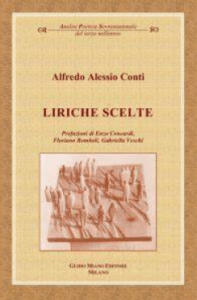ilglomerulodisale 2024
collana La rosa del guardare, diretta da Franca Alaimo
prefazione di Franca Alaimo
con una nota di Daìta Martinez
Nota di lettura: Maria Allo
Lara Pagani, nella sua opera prima, “Le viti del pianto”, per conto della casa editrice “ilglomerulodisale, ci consegna una vita vissuta tutta dal di dentro in una dimensione verticale, perché vibra il sogno di una bellezza che, si affaccia sul deserto, ma con l’alternativa dell’unica scelta consapevole: fra terra e mare è quest’ultimo che corrisponde alla sua vita (“sono l’acqua/ che manca sotto i piedi”). La realtà nella quale lo sguardo dell’autrice si sofferma sui dettagli è densa di circostanze , sfumature, tratti descrittivi che si intrecciano nel tempo, si dimenticano o riaffiorano nella memoria ( “In piazza a Venezia fu l’incubo” p.19, o “Era questione di tempo, di correnti/propizie innamorarmi dall’origine”p.27) per cercare strade da battere esclusivamente entro l’orizzonte del tempo e dello spazio, la sola dimensione che ci appartenga, anche se una frattura insanabile accresce il senso di solitudine dell’io. Così nonostante i tratti descrittivi, qui i particolari diventano emblemi tanto più efficaci quanto più sono realistici, perché, come dice Zanzotto, la poesia ci ridà le emozioni più profonde, che possono nascere in noi. Ma non è sufficiente, il tempo incalza e semina rovine, il passato si dissolve, eppure un incontro, un’emozione vissuta o un pensiero resta solo l’oggetto, che era presente e che, come un amuleto, sembra raccoglierne in sé il segreto: “passi e gli angeli si piegano, girano /le viti del pianto. Dai tuoi dolori /brucia una risata – dal mento d’oro/ spunta al cosmo l’inedito profilo”. Ecco, la poeta non accetta l’idea che della vita vissuta non resti traccia e che il trascorrere del tempo porti con sé emozioni legate a una presenza concreta (“Il filo che ci lega non è rosso. / Non stringe, non fa male eppure/lascia sui quattro polsi un lungo segno invisibile” p. 37), messa in dubbio dall’azione del tempo:” È stata una catastrofe /per sottrazioni, non ha fatto danni /particolari – soltanto ha annullato/giorno per giorno il dono del tempo”. Le viti del pianto presenta pertanto una costruzione complessa e delicatissima che si fonda sull’analogia, ovvero sull’accostamento alogico di elementi disparati, che si caricano di valore allusivo, così la discesa di Clizia, figura metamorfica, (come è stato giustamente osservato da Franca Alaimo nella prefazione), coincide con la possibilità che i valori umanistici resistano alla deriva della storia e i significati delle cose vengano ricercati con gli strumenti della ragione. Tuttavia Clizia si contrappone anche alla lontananza irraggiungibile, in quanto connotata con i caratteri istintivi della sensualità e della corporeità : “avevo le piume /e un bel paio d’ali: ero diventata/uno splendido piccione”(p.16) o in un tentativo di rintracciare sul filo della memoria un passato perduto, resta dunque, pur sempre uno jato , un duplice senso di rimpianto e di desiderio della poeta : “A lampioni eclissati ti ho sfogliato le palpebre –/l’iride tremula, viola come la notte /quando è impossibile da spegnere”. In questa raccolta percorsa dal dolore dell’assenza quasi urlata nel sussulto di una raffinata postura poetica (dalla postfazione di Daita Martinez), il nucleo ispirativo di Lara Pagani tende a coincidere con l’istante di grazia e la sua capacità di cogliere il dono ereditato da Clizia che in questa raccolta si definisce con rigorosa coerenza.
Maria Allo
da: Le viti del pianto (glomerulodisale 2024)
Canto il tuo corpo acquatico –
i polpastrelli senz’ombra
di grinze, le pinne chiare che sono
la tua chioma. Quando trema
la terraferma è il tuo respiro.
*
Cammino sulla sponda del mio mare
che non è calmo, non è tutto azzurro –
azzurri sono gli occhi disegnati
sul viso, quelle gemme che nascondo
come parole perché fanno male.
Lunghi e ramati i miei capelli, sfoggio
un sorriso capace di confondere
i cercatori di perle più avveduti:
non mi avrete, voi bestie – sono l’acqua
che manca sotto i piedi, sono il fuoco
che arretra al solo pensiero di toccarvi.
*
Dei tuoi dolori non fare parola –
tirare dritto fosse l’ultima prova,
l’ultimo incendio della tua figura:
anche questo sei tu, pianeta rosso
per orbite e per anelli che splendono
al dito, nera cometa e sventura
di tutte le solitudini, tu –
passi e gli angeli si piegano, girano
le viti del pianto. Dai tuoi dolori
brucia una risata – dal mento d’oro
spunta al cosmo l’inedito profilo.
*
Ti si può solo ascoltare, sperare
un giorno di somigliarti. I girasoli
che tanto ami hanno appena messo
la testa fuori dal fango, qualcuno
intanto la china. Tu comprendi tutto:
anche morire è una fatica, dici
mentre sgombri la tavola dai resti
del pranzo che non abbiamo diviso.
*
Alla strada che hai disegnato
di fronte a me come qualcuno
che ti spiega le vele e ti prepara
l’amore di una barca penso adesso
che muori in lunghi momenti bianchi.
Ho avuto la fortuna sul collo, la stella
che non brilla bensì trama sotto il ventre
azzurro delle nuvole logorandomi
in altalena la curva dei fianchi.
*
Ricordo il pulviscolo, la prima bruma
ascendente delle stelle. La tua clavicola
mi parlava incrinata, piuma da mordere.
Come arde la memoria, come trama
la luce. Guarda: sembra ancora viva
la piccola donna amata un secolo fa.
*
Il filo che ci lega non è rosso.
Non stringe, non fa male eppure
lascia sui quattro polsi un lungo segno
invisibile. La scia di una cometa
al confronto mi pare una bugia.

Lara Pagani è nata nel 1986 a Lugo (Ravenna), dove vive e lavora. È laureata in lingue e letterature
straniere. Suoi inediti sono apparsi su alcune riviste online, tra cui Atelier, Poetarum Silva, Larosainpiu, Limina Mundi, Le Parole di Fedro, Bottega Portosepolto e Di Sesta e di Settima Grandezza. Le viti del pianto (ilglomerulodisale, 2024) è la sua prima raccolta di poesie.