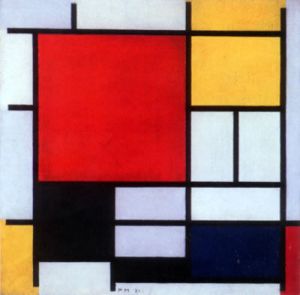Prefazione di Mino Petazzini, postfazione di Alfredo Rienzi.
Illustrazione in copertina di Vania Bellosi
PRIMA PARTE: ANIMALI IN VERSI
Da bambino preferivo le figurine degli animali a quelle dei calciatori; la passione continua. Qualche anno fa ho immaginato che la mia pagina facebook fosse una piccola Arca di Noè dove, ogni settimana, entrava un animale descritto nei versi di poeti italiani contemporanei; da lì ha origine questo mio piccolo bestiario in versi.
La poesia di Saba A mia moglie inizia così: «Tu sei come una giovane, / una bianca pollastra»; i primi due versi de La capra recitano: «Ho parlato a una capra. / Era sola sul prato, era legata»; la poesia La gatta dice: «La tua gattina è diventata magra. / Altro male non è il suo che d’amore». Testi che mantengono una freschezza che il tempo non altera. Alla fine degli anni Quaranta, Saba scrive una raccolta intitolata Uccelli, titolo anche della seguente lirica dove manifesta tutto il suo amore per le creature alate: «L’alata / genia che adoro – ce n’è nel mondo tanta! – / varia d’usi e costumi, ebbra di vita, / si sveglia e canta». Segue nel 1951 Quasi un racconto, che contiene Dieci poesie per un canarino; scelgo la prima dalla giocosa ironia.
A un giovane comunista
Ho in casa – come vedi – un canarino.
Giallo screziato di verde. Sua madre
certo, o suo padre, nacque lucherino.
È un ibrido. E mi piace meglio in quanto
nostrano. Mi diverte la sua grazia,
mi diletta il suo canto.
Torno, in sua cara compagnia, bambino.
[…]
(Antologia del Canzoniere, Einaudi, 1966)
Gli animali da sempre appassionano i poeti e ispirano i loro versi. Penso a due indimenticabili e celebri poesie di Montale: Upupa, ilare uccello calunniato e L’anguilla. L’upupa venne pubblicata nel 1925 in Ossi di seppia. Il fotografo Ugo Mulas scattò nel 1970 un famoso ritratto, in bianco e nero, di Montale: inquadrati di profilo, il poeta e l’uccello (imbalsamato) “calunniato dai poeti” si guardano intensamente, come se
l’uno si specchiasse in qualche modo nell’altro, come se dividessero con amichevole complicità la scena. L’anguilla fu pubblicata su rivista nel 1948 e ne La Bufera e altro nel 1956; scrive Francesco Zambon nella Premessa del volume L’iride nel
fango (Pratiche editrice,1994): «La critica è pressoché unanime nel giudicare L’anguilla uno dei vertici assoluti della poesia di Montale e di tutta la poesia italiana del Novecento»:
L’anguilla
L’anguilla, la sirena
dei mari freddi che lascia il Baltico
per giungere ai nostri mari,
ai nostri estuari, ai fiumi
che risale in profondo, sotto la piena avversa,
[…]
Il cane, il gatto, il pesce rosso, il riccio, lo struzzo, la lince, la pecora, il maiale, la volpe, la mucca, il pollo, il leone, l’oca, il passero, la gallina, la capra, la medusa, la tigre, l’elefante, la tartaruga, il cammello, il bradipo, la chiocciola, il pellicano, il
serpente, il piccione, la locusta, il pappagallo, la scimmia, il camaleonte, il panda, l’orso, la foca, lo scarabeo, il delfino, il lemure, la giraffa, il gufo, il rospo, la balena, sono gli attori e i titoli delle quaranta poesie com rese nella raccolta di Gabriele Galloni Bestiario dei giorni di festa. La maggior parte dei testi è composta di tre versi endecasillabi, il primo fa rima con il terzo. Uscito postumo nel 2020, il libro è stato stampato dalle Edizioni Ensemble con una nota critica di Ilaria Palomba.
Il camaleonte
Somiglia sempre a quello che non è.
A volte è un albero, a volte un’altra bestia –
di notte capita che sembri me.
[…]
Per quanto mi riguarda, ho composto parecchi versi sugli animali, preferibilmente sui volatili. A questi ultimi ho dedicato un libro intitolato I merli del Giardino di san Paolo e altri uccelli. Questa poesia racconta invece di bestioni estinti:
Dinosauri
Il meteorite si presentò
senza concedere alla terra
il tempo per riflettere. La voragine
si spinse così lontana
da impedire alla vista di abbracciarla.
Si alzava un muro polveroso
che faceva supporre cominciasse
da capo la creazione.
Nei dintorni i rettili
morivano soffocati, dinosauri erbivori
scambiarono l’apocalisse
per l’incedere di una specie
colossale di Tirannosauro.
(Cambiamenti, Mobydick, 2001)
[…]
Fra le varie poesie ispirate a Erba dagli amati gatti, quella che prediligo è la seguente:
Il gatto archeologo
a Francesca
[…]
Forse anche il gatto dei Fori
ode con sue lunghe vibrisse
quel che raccontano le pietre
sotto i cieli di tante stelle fisse.
È notte: il gatto archeologo
parte per ricerche di storia romana
ormai nutrito dalle pie donne
nelle aiuole tra archi e colonne.
(Tutte le poesie, Oscar Moderni Mondadori, 2022)
Il critico e poeta Paolo Polvani ha dedicato ai gatti poesie disseminate in diverse raccolte. Questa, dove una gatta innamorata canta alla luna, credo sia inedita:
La gatta per tutta la notte ha cantato
Affacciata sul tetto come a un davanzale
la luna ascoltava. La gatta per tutta la notte
ha cantato. Un richiamo ardente, una lama
di fuoco. Nel vicolo scuro implorava.
Il pozzo del silenzio ne vibrava.
Gli alberi smuovevano le chiome in un sussulto lieve.
La gatta era una piccola dea del buio,
delle finestre chiuse, gorgheggiatrice dolorosa,
assoluta sposa, perfetta dispensatrice
di promesse, voce di tutti i gatti antenati in lei,
geometrie di occhi, vibrisse, la coda voluttuosa,
un calcio negli stinchi del pudore,
una messa cantata dell’amore.
SECONDA PARTE: ANIMALI FANTASTICI
Il Basilisco re dei serpenti
Nel libro ottavo della Storia naturale, dedicato agli animali terrestri, Gaio Plinio Secondo scrive (traduzione e note di Elena Giannarelli, Einaudi, 1983) a proposito del serpente basilisco: «non è più lungo di dodici dita e lo si riconosce per una macchia bianca sulla testa, a mo’ di diadema. Col suo sibilo mette in fuga tutti i serpenti, e non muove il suo corpo, come gli altri, attraverso una serie di volute, ma avanza stando alto e dritto sulla metà del corpo. Secca gli arbusti non solo toccandoli, ma col suo
soffio, brucia le erbe, spezza le pietre: tale potenza ha questo pericoloso animale. Una volta, così si credette, un esemplare fu ucciso da un uomo a cavallo con un’asta e dal veleno salito attraverso di essa non soltanto il cavaliere, ma anche il cavallo furono annientati». Se anziché con un drago San Giorgio, in groppa al suo destriero, si fosse scontrato con un basilisco trafiggendolo, non sarebbe uscito trionfante e vivo dallo scontro. Oltre al nefasto potere di inaridire e intossicare tutto quanto lo circonda, gli viene attribuito anche quello di uccidere con lo sguardo. Vengono immediatamente alla memoria le tre Gorgoni della mitologia greca che pietrificano chi le guarda. Una di loro è Medusa; Caravaggio nel 1598 (opera custodita alla Galleria degli Uffizi) la raffigura così: sguardo sconvolto e allucinato, bocca spalancata in un urlo di disperazione e di dolore, un groviglio impazzito di serpi attorcigliato attor-
no a testa e faccia, un fiotto di sangue che sgorga copioso dal collo dopo che Perseo glielo ha mozzato. Animale ibrido (testa, zampe e ali da gallo; coda di serpente), il basilisco nasce da un uovo di gallo covato da un serpente, da un drago o da un rospo. Vittore Carpaccio, nel dipinto San Trifone ammansisce il basilisco (Scuola di San Giorgio degli Schiavoni, a Venezia), lo dipinge però, nel 1507, come una be-
stia a quattro zampe di taglia media con la testa e le orecchie da asino, corpo leonino, ali di uccello e coda serpentesca. D’altra parte gli animali fantastici subiscono nell’immaginario individuale e collettivo cambiamenti evidenti, ad esempio le Sirene, come ho già detto, vengono pensate inizialmente come donne uccello e successivamente come donne pesce. San Trifone non è il solo capace di placare il basilisco, anche il vescovo San Siro, a Genova, lo rende innocuo. Affronta, armato del solo pastorale, un basilisco che si nasconde dentro un pozzo da dove ammorba l’aria e lo allontana verso il mare. Poco distante dalla chiesa dedicata al Santo, su una
lapide marmorea in latino è scritto: «Qui è il pozzo dal quale il Beatissimo Siro Arcivescovo di Genova fece uscire il terribile serpente di nome Basilisco». Anche se non possiede stazza e mole del drago, il basilisco, grazie al suo straordinario veleno nocivo e letale, è considerato il “basileus” (il re) dei serpenti. Scrivono Jorge Luis Borges e Margarita Guerrero nel Manuale di zoologia fantastica (Einaudi, 1962, traduzione di Franco Lucentini): «Ai suoi piedi cadono morti gli uccelli e imputridiscono i frutti; l’acqua dei ruscelli a cui s’abbevera rimane avvelenata per secoli. […] L’odore della donnola lo uccide. Nel Medioevo, si diceva che l’uccidesse il canto del gallo; e i
viaggiatori esperti si provvedevano di galli per attraversare contrade sconosciute. Altra arma era uno specchio: il basilisco è fulminato dalla sua propria immagine».
Giancarlo Baroni, “Il mio piccolo bestiario in versi”, puntoacapo Editrice, 2025.