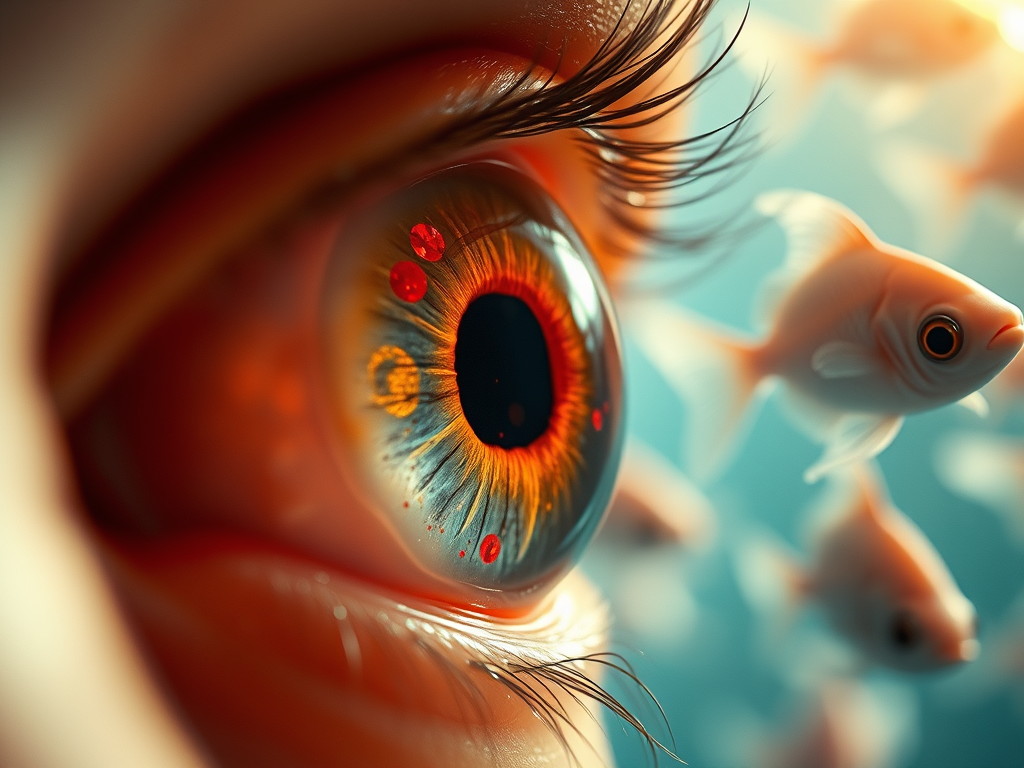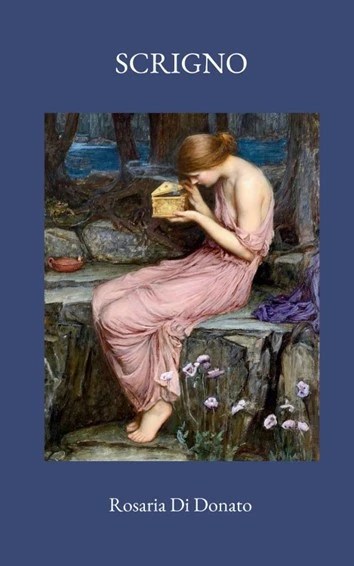Il racconto è tratto da Racconti d’estate, una raccolta di dieci racconti d’amore e d’amicizia attraverso la descrizione di periodi significativi del Novecento, dai primi anni del secolo fino alla caduta delle Torri Gemelle. I protagonisti sono adolescenti che vivono la realtà del loro tempo. Unico filo conduttore: l’estate, che diventa il pretesto per parlare di sentimenti e di modi di manifestarli, che nel corso del tempo sono cambiati nella forma, ma hanno mantenuto la connotazione di scoperta di sé. L’autrice racconta dieci vacanze secondo una successione di periodi estivi che hanno preceduto o seguito momenti significativi del Novecento.
*
2001-Stoccolma, Svezia
Ingrid ha i piedi grossi e me ne sono accorta da un bel pezzo. É una cosa che non posso fare a meno di guardare, quando entra in piscina per gli allenamenti. Indossa il costume colorato con le paillettes, i capelli sono raccolti in uno chignon, le spalle sono dritte, le gambe in linea perfetta con le ginocchia, ma i piedi… quelli sono proprio fuori misura.
“Avessi io solamente quel difetto!” mi ha detto Kristina, una mia compagna di nuoto sincronizzato.
È stata l’unica volta che ho parlato dei piedi di Ingrid con qualcuno. Poi non l’ho fatto più perché tutti l’adorano e questa cosa non la sopporto. Vorrei essere come lei? No. Vorrei che mi adorassero come succede a lei? Sì. Siamo nella stessa squadra di nuoto sincronizzato da un bel pezzo e, col passare del tempo, siamo migliorate e adesso siamo parecchio brave nelle gare di gruppo. Nel sincronizzato singolo me la cavo bene, ma Ingrid è più brava di me. Cosi sembrano pensare le giurie. Poco tempo fa si è piazzata al primo posto nei Campionati regionali e io solo quarta.
“Meglio una medaglia di legno che niente” ha commentato mio padre. “La prossima volta ti piazzerai meglio. Allenati di più. Prendi esempio da Ingrid.”
Anche mio padre adora Ingrid, è evidente. Io la detesto e vorrei che sparisse dalla mia vita, dalla mia piscina, dalle mie gare. Invece resta. E vince. Vince su tutta la linea. Infatti, si è presa anche Sven.
Sven abita a due passi da casa mia e ci conosciamo da molto tempo. Io non l’ho mai preso in considerazione quando eravamo piccoli ma, adesso che stiamo per finire la scuola dell’obbligo e siamo cresciuti, lo guardo con altri occhi. Lui guarda Ingrid e lo trovo intollerabile. Quando finisce gli allenamenti, con la scusa di aspettarmi per tornare a casa insieme, si mette a sedere sulle gradinate e dice di voler seguire i nostri esercizi, ma in realtà guarda solo lei. Lo so perché ogni volta che riemergo dall’acqua, punto lo sguardo su di lui e vedo che non mi tiene proprio in considerazione. Detesto anche lui, da un po’. E avrei voglia di chiedergli che cos’ha di speciale Ingrid, ma tanto so bene che se ne uscirebbe con quelle frasette smozzicate che usa lui quando è in imbarazzo, magari balbetterebbe e cambierebbe discorso. Ieri ho provato il costume da gara nuovo. Mi sono messa davanti allo specchio e non mi sono piaciuta. Il costume non ha colpa perché è bellissimo, con i colori dell’arcobaleno, un velo che lo tiene aderente alle spalle e le paillettes che brillano. Sono io che proprio non vado bene perché mi sono vista le gambe e le ho trovate corte e tozze. Ho guardato le spalle e sono parecchio graciline. Il collo… è corto. Avevo i capelli sciolti e, siccome sono lunghi, mi facevano il collo ancora più corto. Mia madre è intervenuta e me li ha raccolti in uno chignon, ma io ho continuato a vedermi per quello che ero: una ragazzina senza niente di bello. A parte i piedi. Perché quelli li ho perfetti e in una <<gara di piedi» surclasserei Ingrid senza problemi. Mi sono tolta il costume e l’ho messo nella borsa, insieme ai sandali e all’accappatoio. Sven mi aspettava, per andare insieme in piscina. Quando ho aperto la porta, me lo sono ritrovata davanti che mi sorrideva e gli ho detto: «Che c’è da ridere?» e lui ha abbassato la testa e non abbiamo scambiato una sola parola fino alla piscina, dove ci siamo separati. Credo che abbia mormorato il suo solito «a più tardi», ma io non gli ho risposto perché alla sola idea di indossare il costume nuovo davanti alle altre mi sentivo male per la vergogna. Sono tutte più belle di me. Sono tutte più brave di me. Ingrid più di tutte. Nello spogliatoio eravamo eccitate perché è giorno di prova di ammissione, cioè facciamo gli esercizi di squadra e di singolo e il coach decide chi gareggerà e chi no. Io sono sempre in bilico tra l’ammissione e l’esclusione. Oggi non andrà bene, me lo sento. Ingrid è concentratissima come sempre, più di sempre. Difatti, non dice una parola e fa stretching in disparte, gli occhi persi a guardare lo specchio d’acqua della piscina, oltre la vetrata. Lei è fatta così: pensa solo agli esercizi e non si lascia distrarre da niente e da nessuno. Quando il coach ci chiama, lo raggiungiamo. Ingrid arriva per ultima e si tuffa dopo tutte noi. È il suo modo di farsi notare, penso. Lei evita di confondersi con noi, penso. L’esercizio a squadra è andato come doveva andare. Cioè bene, con qualche incertezza.
“Si risolveranno” ha detto il coach fiducioso, e ha ragione.
Gareggiare in gruppo rende tutte noi più capaci di concentrazione, più determinate. Nell’esercizio a squadre, io dimentico i miei difetti e mi focalizzo su quello che devo fare e riesco bene, così tanto che mi dimentico perfino di Ingrid. Solo che poi ci sono anche gli esercizi singoli. Il programma che mi ha dato il coach è difficile.
“È segno che ti ritiene in grado di riuscire al meglio” ha commentato mio padre.
Forse ha ragione e io mi sono impegnata moltissimo, ma il fatto che il coach abbia dato lo stesso livello di difficoltà anche al programma per Ingrid mi fa disperare, perché penso che sia un modo per favorirla. Perfino il coach l’adora e con questa serie di esercizi in acqua è sicuro che avrò incertezze e non sarò perfetta come lei. E siccome andrà come prevedo, sarà Ingrid a gareggiare per il nostro club. Sarà lei a indossare il costume arcobaleno con le paillettes e l’applaudiranno tutti, anche Sven. Sono scesa in acqua con questa convinzione e molta rabbia. Ho fatto la mia prova, secondo il programma previsto dal coach. Tutte le ragazze mi guardavano. Ho sentito gli occhi di Ingrid su di me per tutto il tempo e quando sono risalita dalla scaletta me la sono ritrovata davanti, pronta a tuffarsi. Io ho abbassato la testa e mi sono avvolta nell’accappatoio. Lei è scesa in acqua. Il coach non mi ha detto niente. La musica della prova di Ingrid è partita, mentre Sven si sedeva sulle gradinate in tempo per vederla danzare in acqua. Che tempismo! Mi è venuto da piangere e sono corsa nello spogliatoio. Sotto la doccia ho pianto e non so spiegare per che cosa. Per Sven? Per il mio collo corto? Per le mie gambe tozze? Per Ingrid? Il tempo di chiedermelo non ce l’ho avuto, perché tutte le ragazze sono piombate nello spogliatoio gridando ma, lì per lì, ho capito solo «New York». Ce la sogniamo da tempo la Grande Mela per poterci andare a disputare qualche gara, fare un tour negli Stati Uniti se diventiamo brave a fare un bello spettacolo di sport, però le facce erano tristi e qualcuna piangeva. In un attimo, come erano entrate sono uscite, indossando gli accappatoi. Ingrid gocciolava ancora, per il fatto che doveva essere uscita di corsa dalla piscina. lo le ho seguite e ci siamo ritrovate ad accalcarci davanti alla TV che sta nel gabbiotto del custode. Si vedevano le Torri Gemelle di New York bruciare. Ingrid era accanto a me, la faccia pallidissima e mi sono accorta che tremava, ma forse era per il fatto che era ancora bagnata.
“È la guerra?” ha chiesto Kristina.
“Spero di no” ha mormorato il coach.
“E’ un macello” ha commentato il custode.
Sven, che era li, muto come noi, a guardare le immagini della CNN, si è avvicinato e si è messo tra me e Ingrid. Più vicino a Ingrid che a me. Ho pensato che lo stava facendo per poter consolare Ingrid che tremava davvero come una foglia. Poi, Sven mi ha parlato.
“Hai paura?” mi ha detto sottovoce. “Ci sono io” ha aggiunto, mi si è avvicinato e mi ha stretto la mano. Ed è stato in quel momento che ho cominciato a tremare. Le emozioni si mescolavano: avevo paura per quello che vedevo in TV e che mi sembrava così irreale. E provavo una gioia incontenibile perché Sven mi teneva la mano ed era così reale! Il coach ci ha mandate a casa subito. Però, prima ci ha detto che la prova singola l’avrebbe fatta Ingrid. Mi sarebbe piaciuto sentirgli dire il mio nome? Sì. Mi è dispiaciuto che non abbia detto: «La prova singola la farai tu, Wilma»? No.
Improvvisamente, non me ne importava più niente della gara, della prova, dei premi. Niente.
“Wilma…” ha detto Sven, chiamandomi sottovoce.
E m’è sembrato che fosse la prima volta che lo sentivo dire il mio nome, perché me lo ha detto tendendomi la mano e facendomi un cenno lieve con la testa. Chiamava me, proprio me e mi è nato dentro un sentimento nuovo, come se cominciasse a esistere una Wilma che prima di quel momento non c’era. Mi sono venute delle lacrime di allegria, ma non ho pianto. Ho sussurrato un «sì» e sono uscita dalla piscina con Sven. Sulla via del ritorno, io e Sven abbiamo parlato delle Torri, di New York, della paura e delle gare. E di Ingrid.
“È bella Ingrid” ha detto Sven e ho sentito lo stomaco che si annodava per la gelosia.
“È bravissima” ha aggiunto e ho sentito che il nodo di gelosia si stringeva di più e mi mancava il fiato per parlare.
Ho ritirato la mia mano dalla sua e, per un po’, abbiamo camminato vicini, in silenzio. Sentivo il rumore dei nostri passi e il respiro leggero di Sven che, mentre ci avvicinavamo a casa, mi ha preso di nuovo la mano e io istintivamente gliel’ho stretta, attirandolo verso di me. Lui ha fatto una risatina, prima di dire: «Però… io penso che Ingrid…».
Però… che cosa stava per dire? Mi sentivo gelare.
“Però… ha i piedi grossi” ha concluso, ridacchiando.
“Lo amo” ho pensato abbracciandolo. Prima o poi, glielo dirò.
Luisa Mattia, da Racconti d’estate, Lapis, 2020