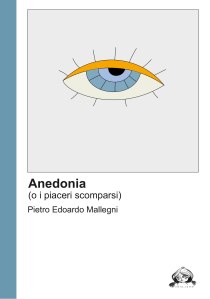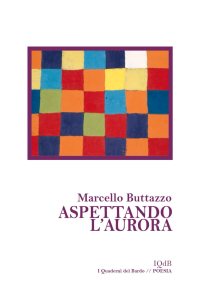Il pedone (The Pedestrian, 1951) è un racconto di fantascienza dello scrittore Ray Bradbury, pubblicato su “The Reporter”. Data l’attenzione rivolta dallo scrittore ai sentimenti e alle relazioni dell’uomo, il genere rientra nel filone della “fantascienza sociologica”. Il suo capolavoro è Fahrenheit 451, romanzo del 1953, che delinea un mondo distopico in cui la televisione costituisce l’unico strumento di svago e di informazione mentre i libri sono vietati e vengono distrutti in grandi roghi pubblici. I mass media, in effetti, riducono l’interesse per la lettura e in molti casi mirano a distrarre dalle questioni importanti controllando il pensiero e indirizzando l’attenzione collettiva in una certa direzione, a sostegno di una certa ideologia. In questo racconto coinvolgente e premonitore, Bradbury descrive la condizione di un pedone in una ipotetica città del 2053: Leonard Mead esce tutte le sere per il piacere di camminare per le strade della città e per prendere aria; allo stesso tempo i suoi concittadini sono nelle loro case davanti alla televisione. Ad un certo punto Leonard viene fermato da un’auto della polizia perché essere fuori casa e camminare sono considerati comportamenti sospetti. Alcune circostanze delle città contemporanee presentano già le caratteristiche descritte dallo scrittore, non occorre guardare al futuro. In una società che non ammette scelte individuali e libertà di pensiero perfino decidere di uscire per fare una passeggiata può apparire un comportamento anomalo dunque da curare.
*
Entrare in quel silenzio che era la città alle otto di un’opaca sera di novembre, sentire sotto le suole quei riquadri di cemento raggrinzito, calpestare l’erba cresciuta fra gli interstizi e aprirsi un varco, con le mani in tasca, in mezzo ai silenzi: era questo che il signor Leonard Mead amava fare sopra ogni altra cosa. Si fermava al primo crocicchio e scrutava i lunari corridoi dei marciapiedi nelle quattro direzioni, come se sceglierne una piuttosto che un’altra facesse qualche differenza. Poi, presa la decisione e stabilito l’itinerario, tornava ad avviarsi, spingendo davanti a sé, come fumo di sigaro, volute d’aria gelida. A volte continuava a camminare per ore e ore, per miglia e miglia, e tornava a casa dopo mezzanotte. E lungo tutta la strada, lungo case e villini dalle finestre buie, era come camminare in un cimitero: con fiochi barlumi di lucciole che baluginavano di quando in quando dietro un vetro; con improvvisi fantasmi grigi che sembravano talvolta manifestarsi sui muri interni delle stanze, là dove una tenda non era stata tirata contro la notte; o con sussurri e mormorii che talvolta giungevano fino a lui, là dove una finestra, in uno dei tanti funerei edifici, era rimasta aperta. Il signor Leonard Mead si fermava, piegava il capo, ascoltava, guardava, e si rimetteva in cammino. Il suo passo, sulle lastre di cemento incrinate e sconnesse, era perfettamente silenzioso; perché, saggiamente, già da molto tempo s’era deciso a portare scarpe con la suola di gomma, per le sue passeggiate notturne: altrimenti i cani avrebbero abbaiato parallelamente a tutto il suo viaggio, e luci si sarebbero accese di colpo, facce sarebbero apparse alle finestre, finché tutta la strada si sarebbe ridestata al passaggio di una figura solitaria, lui, in una sera di novembre. Quella sera Leonard Mead si avviò verso la parte occidentale della città, verso il mare invisibile. C’era nell’aria il presagio cristallino del gelo; pungeva la pelle e, dentro, incendiava i polmoni come un albero di Natale; a ogni respiro, si sentiva la luce fredda accendersi e spegnersi, tutti i rami carichi d’invisibile neve. Rallegrato dai tonfi lievi delle scarpe sulle foglie d’autunno, Leonard Mead prese a fischiettare tra i denti un motivo sommesso, liscio, curvandosi ogni tanto a raccogliere una foglia, esaminando, ripresa la marcia, la sua trama scheletrica alla luce degli infrequenti lampioni, fiutandone l’odore rugginoso.
— Vi saluto, — sussurrava davanti a ogni casa, a destra e a sinistra. — Che c’è di bello stasera sul Quarto Canale, sul Settimo Canale, sul Nono Canale? Dove galoppano i cow boys? È forse la cavalleria degli Stati Uniti che viene alla riscossa, quella nube di polvere sull’altra collina?
La via era silenziosa e lunga e deserta, la sua ombra era l’unica cosa che si muovesse, come l’ombra di un falco sulla pianura. Se chiudeva gli occhi tenendosi perfettamente immobile, impietrito, riusciva a immaginarsi al centro di un’immensa distesa piatta, un arido deserto senza vento e senza una casa nel raggio di mille miglia, con l’unica compagnia di tortuosi fiumi disseccati: le strade.
— Che programma c’è a quest’ora? — chiese alle case, guardando l’orologio. — Le otto e mezzo. È l’ora di mezza dozzina di delitti assortiti? O dei quiz? O di un varietà musicale? O di una scenetta comica?
Era un mormorio di risate quello che usciva da una delle casette bianche di luna? Esitò un istante, ma poi riprese il cammino quando vide che nulla accadeva. Inciampò in un tratto di marciapiedi particolarmente sconnesso. Il cemento spariva, invaso dai fiori e dall’erba. In dieci anni di passeggiate, di giorno e di notte, per migliaia di chilometri, non gli era mai capitato di incontrare un altro essere umano che camminasse come lui per la città; nemmeno uno. Giunse a un incrocio a quadrifoglio, imponente e silenzioso, dove due grandi arterie tagliavano la città. Durante il giorno un vortice assordante di veicoli lo trasformava in un immenso insetto frenetico, velato dai vapori degli scarichi, continuamente dissanguato, dilatato, e poi di nuovo congestionato, soffocato, dall’incessante fluire e defluire del traffico. Ma ora queste grandi strade erano anch’esse corsi d’acqua inariditi, null’altro che asfalto e pietra e chiaro di luna. Imboccò una via laterale per tornare verso casa. Era ormai a un isolato dalla sua porta quando un’automobile solitaria girò di colpo l’angolo e lo centrò con un violento cono di luce. Al primo momento egli rimase immobile; poi, non diversamente da una falena accecata dal bagliore, si sentì attratto verso la fonte.
Una voce metallica suonò nel silenzio:
— Si fermi. Resti dov’è! Non si muova!
Si fermò.
— Mani in alto!
— Ma… — disse.
— Mani in alto! O spariamo!
La polizia, naturalmente. Ma era un caso rarissimo, quasi incredibile: in una città di 3 milioni di abitanti, era rimasta, se ricordava bene, un’unica auto della polizia. Già da un anno ormai, dal 2052, l’anno delle elezioni, le auto in dotazione della polizia erano state ridotte da tre a una sola. La delinquenza era quasi completamente scomparsa; non c’era più bisogno della polizia, quest’ultima auto solitaria che errava senza posa per le vie deserte era più che sufficiente.
— Nome e cognome, — disse l’auto della polizia in un ronzio metallico.
Non gli riuscì di vedere gli uomini dentro la macchina, accecato com’era dalla luce bianca.
— Leonard Mead, – rispose.
— Parli più forte!
— Leonard Mead!
— Impiego o occupazione?
— Diciamo, scrittore.
— Senza occupazione, — disse l’auto della polizia, come parlando tra sé. Il fascio di luce lo teneva inchiodato come un esemplare da museo, un insetto col corpo trapassato da uno spillo.
— Non avete torto, — disse Leonard Mead. Da anni aveva smesso di scrivere: Libri e riviste non si vendevano più. Tutto – pensò, tornando alle sue meditazioni d’ogni sera, – tutto ormai si svolgeva di sera, dentro quei sepolcri di case appena illuminati dal tenue riflesso dello schermo televisivo, in cui gli uomini, simili a defunti, sedevano davanti alle luci grigie o multicolori che sfioravano i loro volti ma senza mai toccarli dentro.
— Senza occupazione, — disse la voce di fonografo, sibilando.
— Perché è uscito di casa?
— Per camminare, — disse Leonard Mead.
— Camminare!
— Solo camminare, — disse con naturalezza, ma mentre un gelo gli saliva lungo la schiena.
— Camminare, solo camminare, camminare?
— Sissignore.
— Camminare dove? A che scopo?
— Camminare per prendere aria. Camminare per vedere.
— Il suo indirizzo, prego?
— Saint James Street, numero 11.
— E lei ha dell’aria, in casa sua, signor Mead? Ha un condizionatore d’aria?
— Sì.
— E ha uno schermo televisivo in casa? Uno schermo da guardare?
— No.
— No? — Vi fu un silenzio crepitante che era di per sé un’accusa.
— Lei è sposato, signor Mead?
— No.
— Celibe, — disse la voce della polizia dietro il raggio accecante.
La luna era alta e chiara fra le stelle e le case grigie e silenziose.
— Nessuno mi ha voluto, — disse Leonard Mead con un sorriso.
— Non parli se non è interrogato.
Leonard Mead rimase in attesa nella notte fredda.
— E uscito da solo, per camminare, signor Mead?
— Sì.
— Ma non ci ha detto per quale scopo.
— Ve l’ho detto: per prendere aria, per vedere, e per il piacere di camminare.
— Lo fa spesso?
— L’ho fatto per anni, tutte le sere.
L’auto della polizia era acquattata al centro della strada con la sua gola radiofonica che ronzava fiocamente.
— Bene, signor Mead, — disse.
— Non c’è altro? — chiese educatamente Mead.
— No, — disse la voce. — È tutto —. Vi fu uno scatto metallico e come un lungo sospiro.
Lo sportello posteriore della macchina della polizia si aprì lentamente. — Salga.
— Un momento, io non ho fatto niente!
— Salga.
— Io protesto. Non avete il diritto di…
— Signor Mead.
Leonard Mead avanzò rassegnato, vacillando appena, ma con le spalle improvvisamente curve. Mentre passava davanti al parabrezza guardò nell’interno dell’auto. Come si aspettava, non c’era nessuno seduto sul sedile anteriore; non c’era nessuno nella macchina.
— Salga.
Posò una mano sullo sportello e scrutò nel sedile posteriore, che era una piccola cella, una piccola prigione nera, con le sbarre. Odorava di acciaio. Odorava di pungente antisettico. Odorava di gelida pulizia, di duro metallo. Non c’era nulla di soffice là dentro.
— Se lei fosse sposato, e sua moglie potesse testimoniare, — disse la voce di ferro. — Ma così come stanno le cose…
— Dove mi portate?
La macchina esitò, o piuttosto emise un leggero, brevissimo ronzio, e uno scatto, come se un braccio meccanico, nel suo interno, chissà dove, facesse scorrere una serie di schede sotto un occhio elettrico. — Al Centro di Ricerca Psichiatrica sulle Tendenze Regressive.
Leonard Mead salì. Lo sportello si richiuse con un tonfo morbido. L’auto scivolò via tra i viali notturni, preceduta dai suoi fari fiochi.
Un istante dopo passarono davanti a una certa casa, in una certa via, l’unica casa in una città di case buie, che avesse tutte le sue luci accese, ogni finestra viva e rutilante, ogni rettangolo caldo e chiaro nel buio di novembre.
— Quella è casa mia, — disse Leonard Mead.
Nessuno gli rispose.
L’auto continuò la corsa lungo i fiumi inariditi, lasciandosi dietro strade deserte e deserti marciapiedi, dove non un suono, non un movimento turbavano più la fredda notte d’autunno.
Ray Bradbury, Il pedone, in Il secondo libro della fantascienza, a cura di Carlo Fruttero e Franco Lucentini, Einaudi, 1961.