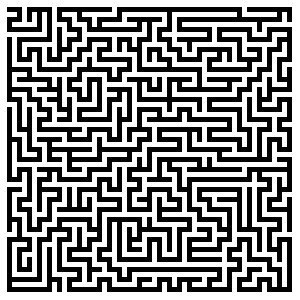“Sette piani” è un racconto breve di Dino Buzzati, scritto nel 1937 e inserito dapprima nell’antologia I sette messaggeri del 1942 e successivamente nella raccolta dal titolo “Sessanta racconti” del 1968.
La storia vede il protagonista, l’avvocato Giuseppe Corte, ricoverarsi in un ospedale per fare degli accertamenti e curare la leggerissima forma di malattia da cui è affetto. L’ospedale in questione ha una particolarità: ogni piano dei sette che lo costituiscono categorizza i pazienti in base alla gravità della loro malattia. Il Corte viene accolto subito al settimo piano, in attesa di guarire dalla malattia e quindi di poter tornare a casa, qui sono accettati i pazienti che devono fare solo degli accertamenti diagnostici di poco conto e che trascorrono il tempo della degenza come se si trattasse di una villeggiatura. Man mano che si scende, la gravità dello stato di salute dei pazienti aumenta fino ad arrivare al primo piano, dove le finestre sono sempre chiuse e su cui anche lo sguardo dei degenti dei piani alti non indugia per paura e scaramanzia. Dopo qualche giorno di permanenza, a Giuseppe Corte viene chiesto, con una scusa banale, di scendere al piano di sotto, in via temporanea. Ai suoi nuovi compagni di piano Giuseppe precisa che lui è del piano superiore dove, al più presto tornerà. Le cose però non andranno così. Corte si arrabbia, dibatte e litiga con i dottori per quella che ritiene un’ingiustizia e alle infermiere ribadisce che non è malato. Non si cura di quello che avviene dentro di lui, della “vera” malattia, su cui anche il lettore rimane all’oscuro. Proietta all’esterno il problema, vuole e pretende solo di stare tra i “sani” ma cade nella solitudine, nella frustrazione e nell’impotenza. Il racconto è degno del miglior Buzzati, quello dei paesaggi introspettivi e desolati del “Deserto dei Tartari”, in questo caso però l’autore ci conduce all’interno del mondo sanitario. Quando scrive il suo racconto infatti si è in pieno periodo dello sviluppo dei grandi sanatori che accoglievano i pazienti affetti da TBC e da altri mali e fin da allora gerarchizzavano la cura attraverso il rispetto di terapie e protocolli. Il racconto offre una efficace metafora del mondo sanitario, dell’assistenza medica e infermieristica e ben rappresenta lo stillicidio che vive il Corte che coltiva sempre la speranza di tornare ai piani alti ma si rende conto della precarietà della salute. Dal racconto di Buzzati ne è stata tratta una pièce teatrale rappresentata per la prima volta al Piccolo Teatro di Milano nel 1953 e successivamente riproposta in molte città europee con il titolo: “Un caso clinico”. L’attore Ugo Tognazzi ne farà un film nel 1967: “Il fischio al naso”, e per la televisione, qualche anno dopo, Aroldo Tieri riprenderà la trasposizione curata da Albert Camus e rappresentata al Théatre La Bruyère nel 1955.
*
Dopo un giorno di viaggio in treno, Giuseppe Corte arrivò, una mattina di marzo, alla città dove c’era la famosa casa di cura. Aveva un po’ di febbre, ma volle fare ugualmente a piedi strada fra la stazione e l’ospedale, portandosi la sua valigetta. Benché avesse soltanto una leggerissima forma incipiente, Giuseppe Corte era stato consigliato di rivolgersi al celebre sanatorio, dove non si curava che quell’unica malattia. Ciò garantiva un’eccezionale competenza nei medici e la più razionale ed efficace sistemazione d’impianti. Quando lo scorse da lontano – e lo riconobbe per averne già visto la fotografia in una circolare pubblicitaria – , Giuseppe Corte ebbe un’ottima impressione. Il bianco edificio a sette piani era solcato da regolari rientranze che gli davano una fisionomia vaga d’albergo. Tutt’attorno era una cinta di alti alberi. Dopo una sommaria visita medica, in attesa di un esame più accurato Giuseppe Corte fu messo in una gaia camera del settimo ed ultimo piano. I mobili erano chiari e lindi come la tappezzeria, le poltrone erano di legno, i cuscini rivestiti di policrome stoffe. La vista spaziava su uno dei più bei quartieri della città. Tutto era tranquillo, ospitale e rassicurante. Giuseppe Corte si mise subito a letto e, accesa la lampadina sopra il capezzale, cominciò a leggere un libro che aveva portato con sé… Poco dopo entrò un’infermiera per chiedergli se desiderasse qualcosa… Giuseppe Corte non desiderava nulla ma si mise volentieri a discorrere con la giovane, chiedendo informazioni sulla casa di cura. Seppe così la strana caratteristica di quell’ospedale. I malati erano distribuiti piano per piano a seconda della gravità. Il settimo, cioè l’ultimo, era per le forme leggerissime. Il sesto era destinato ai malati non gravi ma neppure da trascurare. Al quinto si curavano già affezioni serie e così di seguito, di piano in piano. Al secondo erano i malati gravissimi. Al primo, quelli per cui era inutile sperare. Questo singolare sistema, oltre a sveltire grandemente il servizio, impediva che un malato leggero potesse venir turbato dalla vicinanza di un collega in agonia, e garantiva in ogni piano un’atmosfera omogenea. D’altra parte la cura poteva venir così graduata in modo perfetto. Ne derivava che gli ammalati erano divisi in sette progressive caste. Ogni piano era come un piccolo mondo a sé, con le sue particolari regole, con le sue speciali tradizioni. E siccome ogni settore era affidato a un medico diverso, si erano formate, sia pure minime, ma precise differenze nei metodi di cura, nonostante il direttore generale avesse impresso all’istituto un unico fondamentale indirizzo. Quando l’infermiera fu uscita, Giuseppe Corte, sembrandogli che la febbre fosse scomparsa, raggiunse la finestra e guardò fuori, non per osservare il panorama della città, che pure era nuovo per lui, ma nella speranza di scorgere, attraverso le finestre, altri ammalati dei piani inferiori. La struttura dell’edificio, a grandi rientranze, permetteva tale genere di osservazione. Soprattutto Giuseppe Corte concentrò la sua attenzione sulle finestre del primo piano che sembravano lontanissime, e che si scorgevano solo di sbieco. Ma non poté vedere nulla di interessante. La maggioranza erano ermeticamente sprangate dalle grigie persiane scorrevoli.
Il Corte si accorse che a una finestra di fianco alla sua stava affacciato un uomo. I due si guardarono a lungo con crescente simpatia, ma non sapevano come rompere il silenzio. Finalmente Giuseppe Corte si fece coraggio e disse: “Anche lei sta qui da poco?”
“0h no – fece l’altro – sono qui già da due mesi…” tacque qualche istante e poi, non sapendo come continuare la conversazione, aggiunse: “Guardavo giù mio fratello.”
“Suo fratello?”
“Sì.” spiegò lo sconosciuto. “Siamo entrati insieme, un caso veramente strano, ma lui è andato peggiorando, pensi che adesso è già al quarto.”
“Al quarto che cosa?”
“Al quarto piano” spiegò l’individuo e pronunciò le due parole con una tale espressione di commiserazione e di orrore, che Giuseppe Corte restò quasi spaventato.
“Ma son così gravi al quarto piano?” domandò cautamente.
“Oh Dio” fece l’altro, scuotendo lentamente la testa “non sono ancora così disperati, ma comunque poco da stare allegri.”
“Ma allora”, chiese ancora il Corte, con una scherzosa disinvoltura come di chi accenna a cose tragiche che non lo riguardano, “allora, se al quarto sono già così gravi, al quinto chi mettono allora?” “0h, al primo sono proprio i moribondi. Laggiù i medici non hanno più niente da fare. C’è solo il prete che lavora. E naturalmente…”
“Ma ce n’è pochi al primo piano” interruppe Giuseppe Corte, come se gli premesse di avere una conferma “quasi tutte le stanze sono chiuse laggiù.”
“Ce n’è pochi, adesso, ma stamattina ce n’erano parecchi” rispose lo sconosciuto con un sottile sorriso. “Dove le persiane sono abbassate lì qualcuno è morto da poco. Non vede, del resto, che negli altri piani tutte le imposte sono aperte? Ma mi scusi, aggiunse ritraendosi lentamente “mi pare che cominci a far freddo. Io ritorno in letto.
Auguri, auguri…”
L’uomo scomparve dal davanzale e la finestra venne chiusa con energia; poi si vide accendersi dentro una luce. Giuseppe Corte se ne stette ancora immobile alla finestra fissando le persiane abbassate del primo piano. Le fissava con un’intensità morbosa, cercando di immaginare i funebri segreti di quel terribile primo piano dove gli ammalati venivano confinati a morire; e si sentiva sollevato di sapersene cosi lontano. Sulla città scendevano intanto le ombre della sera. Ad una ad una le mille finestre del sanatorio si illuminavano, da lontano si sarebbe potuto pensare a un palazzo in festa. Solo al primo piano, laggiù in fondo al precipizio, decine e decine di finestre rimanevano cieche e buie. Il risultato della visita medica generale rasserenò Giuseppe Corte. Incline di solito a prevedere il peggio, egli si era già in cuor suo preparato a un verdetto severo, e non sarebbe rimasto sorpreso se il medico gli avesse dichiarato di doverlo assegnare al piano inferiore. La febbre infatti non accennava a scomparire, nonostante le condizioni generali si mantenessero buone. Invece il sanitario gli rivolse parole cordiali e incoraggianti. Un principio di male c’era – gli disse – ma leggerissimo; in due o tre settimane probabilmente tutto sarebbe passato. “E allora resto al settimo piano?” aveva domandato ansiosamente Giuseppe Corte a questo punto. “Ma naturalmente!” gli aveva risposto il medico battendogli amichevolmente una mano su una spalla. E dove pensava di dover andare? Al quarto forse? chiese ridendo, come per alludere alla ipotesi più assurda. “Meglio così, meglio così!” fece il Corte. “Sa? Quando si è ammalati si immagina sempre il peggio”. Giuseppe Corte infatti rimase nella stanza che gli era stata assegnata originariamente. Imparò a conoscere alcuni dei suoi compagni di ospedale, nei rari pomeriggi in cui gli veniva concesso d’alzarsi. Seguì scrupolosamente la cura, mise tutto l’impegno a guarire rapidamente, ma ciononostante le sue condizioni pareva rimanessero stazionarie. Erano passati circa dieci giorni, quando a Giuseppe Corte si presentò il capo-infermiere del settimo piano. Aveva da chiedere un favore in via puramente amichevole: il giorno dopo doveva entrare all’ospedale una signora con due bambini; due camere erano, libere, proprio di fianco alla sua, ma mancava la terza; non avrebbe consentito il signor Corte a trasferirsi in un’altra camera, altrettanto confortevole? Giuseppe Corte non fece naturalmente nessuna difficoltà; una camera o un’altra per lui erano lo stesso; gli sarebbe anzi toccata forse una nuova e più graziosa infermiera. “La ringrazio di cuore”, fece allora il capo-infermiere con un leggero inchino; da una persona come lei le confesso non mi stupisce un così gentile atto di cavalleria. Fra un’ora, se lei non ha nulla in contrario, procederemo al trasloco. Guardi che bisogna scendere al piano di sotto” aggiunse con voce attenuata come se si trattasse di un particolare assolutamente trascurabile. “Purtroppo in questo piano non ci sono altre camere libere. Ma è una sistemazione assolutamente provvisoria, ” si affrettò a specificare vedendo che Corte, rialzatosi di colpo a sedere, stava per aprir bocca in atto di protesta, “una sistemazione assolutamente provvisoria. Appena resterà libera una stanza, e credo che sarà fra due o tre giorni, lei potrà tornare di sopra.”
“Le confesso”, disse Giuseppe Corte sorridendo, per dimostrare di non essere un bambino “le confesso che un trasloco di questo genere non mi piace affatto.”
“Ma non ha alcun motivo medico questo trasloco; capisco benissimo quello che lei intende dire, si tratta unicamente di una cortesia a questa signora che preferisce non rimaner separata dai suoi bambini… Per carità”, aggiunse ridendo apertamente “non le venga neppure in mente che ci siano altre ragioni”. “Sarà”, disse Giuseppe Corte “ma mi sembra di cattivo augurio”. Corte così passò al sesto piano, e sebbene fosse convinto che questo trasloco non corrispondesse a un peggioramento del male, si sentiva a disagio al pensiero che tra lui e il mondo normale, della gente sana, già si frapponesse un netto ostacolo. Al settimo piano, porto d’arrivo, si era in un certo modo ancora in contatto con il consorzio degli uomini; esso si poteva anzi considerare quasi un prolungamento del mondo abituale. Ma al sesto già si entrava nel corpo autentico dell’ospedale; già la mentalità dei medici, delle infermiere e degli stessi ammalati era leggermente diversa. Già si ammetteva che a quel piano venivano accolti dei veri e propri ammalati, sia pure in forma non grave. Dai primi discorsi fatti con i vicini di stanza, con il personale e con i sanitari, Giuseppe Corte si accorse come in quel reparto, il settimo piano venisse considerato come uno scherzo, riservato ad ammalati dilettanti, affetti più che altro da fisime; solo dal sesto, per così dire, si cominciava davvero. Comunque Giuseppe Corte capì che per tornare di sopra, al posto che gli competeva per le caratteristiche del suo male, avrebbe certamente incontrato qualche difficoltà; per tornare al settimo piano, egli doveva mettere in moto un complesso organismo, sia pure per un minuto sforzo; non c’era dubbio che se egli non avesse fiatato, nessuno avrebbe pensato a trasferirlo di nuovo al piano superiore dei “quasi-sani”.
Giuseppe Corte si propose perciò di non transigere sui suoi diritti e di non cedere alle lusinghe dell’abitudine. Ai compagni di reparto teneva molto a specificare che trovarsi con loro, soltanto per pochi giorni, ch’era stato lui a voler scendere d’un piano per fare un piacere a una signora, e che appena fosse rimasta libera una stanza sarebbe tornato di sopra. Gli altri lo ascoltavano senza interesse e annuivano con scarsa convinzione. II convincimento di Giuseppe Corte trovò piena conferma nel giudizio del nuovo medico. Anche questi ammetteva che Giuseppe Corte poteva benissimo essere assegnato al settimo piano; la sua forma era as-so-lu-ta-men-te leg-ge-ra e scandiva tale definizione per darle importanza – ma in fondo riteneva che al sesto piano Giuseppe Corte forse potesse essere meglio curato. “Non cominciamo con queste storie”, interveniva a questo punto il malato con decisione. “Lei mi ha detto che il settimo piano è il mio posto e voglio ritornarci”. “Nessuno ha detto il contrario”. ribatteva il dottore
“il mio era un puro e semplice consiglio non da dot-to-re, ma da au-ten-ti-co a-mi-co! La sua forma, le ripeto, è leggerissima, non sarebbe esagerato dire che lei non è nemmeno ammalato, ma secondo me si distingue da forme analoghe per una certa maggiore estensione. Mi spiego: l’intensità del male è minima, ma considerevole l’ampiezza; il processo distruttivo delle cellule” (era la prima volta che Giuseppe Corte sentiva là dentro quella sinistra espressione “il processo distruttivo delle cellule”) è assolutamente agli inizi, forse non è neppure cominciato, ma tende, dico, solo tende, a colpire contemporaneamente vaste porzioni dell’organismo. Solo per questo, secondo me, lei può essere curato più efficacemente qui, al sesto, dove i metodi terapeutici sono più tipici ed intensi. Un giorno gli fu riferito che il direttore generale della casa di cura, dopo essersi lungamente consultato con i suoi collaboratori, aveva deciso un mutamento nella suddivisione dei malati. Il grado di ciascuno di essi – per così dire – veniva ribassato di un mezzo punto. Ammettendosi che in ogni piano gli ammalati fossero divisi, a seconda della loro gravità, in due categorie, (questa suddivisione veniva effettivamente fatta dai rispettivi medici, ma ad uso esclusivamente interno) l’inferiore di queste due metà veniva d’ufficio traslocata a un piano più basso. Ad esempio, la metà degli ammalati del sesto piano, quelli con forme leggermente più avanzate, dovevano passare al quinto; e i meno leggeri del settimo piano passare al sesto. La notizia fece piacere a Giuseppe Corte, perché in un così complesso quadro di traslochi, il suo ritorno al settimo piano sarebbe riuscito assai più facile. Quando accennò a questa sua speranza con l’infermiera egli ebbe però un’amara sorpresa. Seppe cioè che egli sarebbe stato traslocato, ma non al settimo, bensì al piano di sotto. Per motivi che l’infermiera non sapeva spiegargli, egli era stato compreso nella metà più “grave” degli ospiti del sesto piano e doveva perciò scendere al quinto. Passata la prima sorpresa, Giuseppe Corte andò in furore; gridò che lo truffavano, che non voleva sentir parlare di altri traslochi in basso, che se ne sarebbe tornato a casa, che i diritti erano diritti e che l’amministrazione dell’ospedale non poteva trascurare così sfacciatamente le diagnosi dei sanitari. Mentre egli ancora gridava arrivò il medico per tranquillizzarlo. Consigliò al Corte di calmarsi se non avesse voluto veder salire la febbre, gli spiegò che era successo un malinteso, almeno parziale. Ammise ancora una volta che Giuseppe Corte sarebbe stato al suo giusto posto se lo avessero messo al settimo piano, ma aggiunse di avere sul suo caso un concetto leggermente diverso, se pure personalissimo. In fondo in fondo la sua malattia poteva, in un certo senso s’intende, essere anche considerata di sesto grado, data l’ampiezza delle manifestazioni morbose. Lui stesso però non riusciva a spiegarsi come il Corte fosse stato catalogato nella metà inferiore del sesto piano. Probabilmente il segretario della direzione, che proprio quella mattina gli aveva telefonato chiedendo l’esatta posizione clinica di Giuseppe Corte, si era sbagliato nel trascrivere. o meglio la direzione aveva di proposito leggermente “peggiorato” il suo giudizio, essendo egli ritenuto un medico esperto ma troppo indulgente. Il dottore infine consigliava il Corte a non inquietarsi, a subire senza proteste il trasferimento; quello che contava era la malattia, non il posto in cui veniva collocato un malato. Per quanto si riferiva alla cura – aggiunse ancora il medico – Giuseppe Corte non avrebbe poi avuto da rammaricarsi; il medico del piano di sotto aveva certo più esperienza; era quasi dogmatico che l’abilità dei dottori andasse crescendo, almeno a giudizio della direzione, man mano che si scendeva. La camera era altrettanto comoda ed elegante. La vista ugualmente spaziosa: solo dal terzo piano in giù la visuale era tagliata dagli alberi di cinta. Giuseppe Corte, in preda alla febbre serale, ascoltava ascoltava le meticolose giustificazioni con una progressiva stanchezza. Alla fine si accorse che gli mancavano la forza e soprattutto la voglia di reagire ulteriormente all’ingiusto trasloco. E senza altre proteste si lasciò portare al piano di sotto. L’unica, benché povera, consolazione di Giuseppe Corte, una volta che si trovò al quinto piano, fu di sapere che per giudizio concorde di medici, di infermieri e ammalati, egli era in quel reparto il menu grave di tutti. Nell’ambito di quel piano insomma egli poteva considerarsi di gran lunga il più fortunato. Ma d’altra parte lo tormentava il pensiero che oramai ben due barriere si frapponevano fra lui e il mondo della gente normale. Procedendo la primavera, l’aria intanto si faceva più tepida, ma Giuseppe Corte non amava più come nei primi giorni affacciarsi alla finestra; benché un simile timore fosse una pura sciocchezza, egli si sentiva rimescolare tutto da uno strano brivido alla vista delle finestre del primo piano, sempre nella maggioranza chiuse, che si erano fatte assai più vicine. Il suo male sembrava stazionario. Dopo tre giorni di permanenza al quinto piano, si manifestò anzi sulla gamba destra una specie di eczema che non accennò a riassorbirsi nei giorni successivi. Era un’affezione – gli disse il medico – assolutamente indipendente dal male principale; un disturbo che poteva capitare alla persona più sana del mondo. Ci sarebbe voluta, per eliminarlo in pochi giorni, una intensa cura di raggi digamma.
“E non si possono avere qui i raggi digamma?”, chiese Giuseppe Corte.
“Certamente” rispose compiaciuto il medico, “il nostro ospedale dispone di tutto. C’è un solo inconveniente….
“Che cosa?” fece il Corte con un vago presentimento.
“Inconveniente per modo di dire”. si corresse il dottore, “volevo dire che l’installazione per i raggi si trova soltanto al quarto piano e io le sconsiglierei di fare tre volte al giorno un simile tragitto”.
“E allora niente?”
“Allora sarebbe meglio che fino a che l’espulsione non sia passata lei avesse la compiacenza di scendere al quarto.”
“Basta!” urlò allora esasperato Giuseppe Corte. Ne ho già abbastanza di scendere! Dovessi crepare, al quarto non ci vado!”
“Come lei crede” fece conciliante il medico per non irritarlo “come medico curante, badi che le proibisco di andar da basso tre volte al giorno”.
Il brutto fu che l’eczema, invece di attenuarsi, andò lentamente ampliandosi. Giuseppe Corte non riusciva a trovare requie e continuava a rivoltarsi nel letto. Durò così, rabbioso, per tre giorni, fino a che dovette cedere. Spontaneamente pregò il medico di fargli praticare la cura dei raggi e di essere trasferito al piano inferiore. Quaggiù il Corte notò, con inconfessato piacere, di rappresentare un’eccezione. Gli altri ammalati del reparto erano decisamente in condizioni molto serie e non potevano lasciare neppure per un minuto il letto. Egli invece poteva prendersi il lusso di raggiungere a piedi, dalla sua stanza, la sala dei raggi, fra i complimenti e la meraviglia delle stesse infermiere. Al nuovo medico, egli precisò con insistenza la sua posizione specialissima. Un ammalato che in fondo aveva diritto al settimo piano veniva a trovarsi al quarto. Appena l’espulsione fosse passata, egli intendeva ritornare di sopra. Non avrebbe assolutamente ammesso alcuna nuova scusa. Lui, che sarebbe potuto trovarsi legittimamente ancora al settimo.
“Al settimo, al settimo!.” esclamò sorridendo il medico, che finiva proprio allora di visitarlo. Sempre esagerati voi ammalati. Sono il primo io a dire che lei può essere contento del suo stato; a quanto vede, dalla tabella clinica, grandi peggioramenti non ci sono stati. Ma da questo a parlare di settime, piano – mi scusi la brutale sincerità – c’è una certa differenza! Lei è uno dei casi meno preoccupanti, ne convengo io, ma è pur sempre un ammalato!”
“E allora, allora” fece Giuseppe Corte accendendosi tutto nel volto, “lei a che piano mi metterebbe?”
“0h, Dio, non è facile dire, non le ho fatto che una breve visita, per poter pronunciarmi dovrei seguirla per almeno una settimana.”
“Va bene” insistette Corte “ma pressapoco lei saprà”
Il medico per tranquillizzarlo, fece finta di concentrarsi un momento in meditazione e poi, annuendo con il capo a se stesso, disse lentamente: “Oh Dio, proprio per accontentarla, ecco, ma potremo in fondo metterla al sesto!”
“Sì sì” aggiunse come per persuadere se stesso. “Il sesto potrebbe andar bene.”
II dottore credeva così di far lieto il malato. Invece sul volto di Giuseppe Corte si diffuse un’espressione di sgomento: si accorgeva, il malato, che i medici degli ultimi piani l’avevano ingannato; ecco, qui questo nuovo dottore, evidentemente più abile e più onesto, che in cuor suo – era evidente – lo assegnava, non al settimo, ma al quinto piano, e forse al quinto inferiore! La delusione inaspettata prostrò il Corte. Quella sera la febbre salì sensibilmente. La permanenza al quarto piano segnò il periodo più tranquillo passato da Giuseppe Corte dopo l’entrata all’ospedale. Il medico era persona simpaticissima, premurosa e cordiale; si tratteneva spesso anche per delle ore intere a chiacchierare degli argomenti più svariati. Giuseppe Corte discorreva pure molto volentieri, cercando argomenti che riguardassero la sua solita vita d’avvocato e d’uomo di mondo. Egli cercava di persuadersi di appartenere ancora al consorzio degli uomini sani, di essere ancora legato al mondo degli affari, di interessarsi veramente dei fatti pubblici. Cercava, senza riuscirvi. Invariabilmente il discorso finiva sempre per cadere sulla malattia. Il desiderio di un miglioramento qualsiasi era divenuto in Giuseppe Corte un’ossessione. Purtroppo i raggi digamma, se erano riusciti ad arrestare il diffondersi dell’espulsione cutanea, non erano bastati ad eliminarla. Ogni giorno Giuseppe Corte ne parlava lungamente col medico e si sforzava in questi colloqui di mostrarsi forte, anzi ironico, senza mai riuscirvi.
“Mi dica, dottore. disse un giorno, come va il processo distruttivo delle mie cellule?”
“0h, ma che brutte parole!” lo rimproverò scherzosamente il dottore. “Dove mai le ha imparate? Non sta bene, non sta bene, soprattutto per un malato! Mai più voglio sentire da lei discorsi simili”
“Va bene” obiettò il Corte “ma così lei non mi ha risposto”
“0h, le rispondo subito” fece il dottore cortese. “Il processo distruttivo delle cellule, per ripetere la sua orribile espressione, è, nel suo caso minimo, assolutamente minimo. Ma sarei tentato di definirlo ostinato” “Ostinato, cronico vuol dire?”
“Non mi faccia dire quello che non ho detto. lo voglio dire soltanto ostinato. Del resto sono così la maggioranza dei casi. Affezioni anche lievissime spesso hanno bisogno di cure energiche e lunghe”
“Ma mi dica, dottore, quando potrò sperare in un miglioramento?”
“Quando? Le predizioni in questi casi sono piuttosto difficili… Ma senta” aggiunse dopo una pausa meditativa “vedo che lei ha una vera e propria smania di guarire… se non temessi di farla arrabbiare, sa che cosa le consiglierei?”
“Ma dica, dica pure, dottore….”
“Ebbene, le pongo la questione in termini molto chiari. Se io, colpito da questo male in forma anche tenuissima, capitassi in questo sanatorio, che è forse il migliore che esista, mi farei assegnare spontaneamente, e fin dal primo giorno, fin dal prima giorno, capisce? a uno dei piani più bassi. Mi farei mettere addirittura al….”
“Al primo?” suggerì con uno sforzato sorriso il Corte.
“Oh no! al primo no!” rispose ironico il medico, “questo poi no! Ma al terzo o anche al secondo di certo. Nei piani inferiori la cura è fatta molto meglio, le garantisco, gli impianti sono più completi e potenti, il personale è più abile. Lei sa poi chi è l’anima di questo ospedale?”
“Non è il professor Dati?”
“Già il professor Dati. E’ lui I’inventore della cura che qui si pratica, lui il progettista dell’intero impianto. Ebbene, lui, il maestro, sta, per così dire, fra il primo e il secondo piano. Di là irraggia la sua forza direttiva. Ma, glielo garantisco io, il suo influsso non arriva oltre al terzo piano; più in là si direbbe che gli stessi suoi ordini si sminuzzino, perdano di consistenza, deviino; il cuore dell’ospedale è in basso e in basso bisogna stare per avere le cure migliori”
“Ma insomma” fece Giuseppe Corte con voce tremante, “allora lei mi consiglia …”
“Aggiunga una cosa” continuò imperterrito il dottore “aggiunga che nel suo caso particolare ci sarebbe da badare anche all’espulsione. Una cosa di nessuna importanza ne convengo, ma piuttosto noiosa, che a lungo andare potrebbe deprimere il suo “morale”; e lei sa quanto è importante per la guarigione la serenità di spirito. Le applicazioni di raggi che io le ho fatte sono riuscite solo a metà fruttuose. Il perché può darsi che sia un puro caso, ma può darsi anche che i raggi non siano abbastanza intensi. Ebbene, al terzo piano le macchine dei raggi sono molto più potenti. Le probabilità di guarire il suo eczema sarebbero molto maggiori. Poi vede? una volta avviata la guarigione, il passo più difficile è fatto. Quando si comincia a risalire, è poi difficile tornare ancora indietro. Quando lei si sentirà davvero meglio, allora nulla impedirà che lei risalga qui da noi o anche più in su, secondo i suoi “meriti” anche al quinto, al sesto, persino al settimo oso dire”
“Ma lei crede che questo potrà accelerare la cura?”
“Ma non ci può essere dubbio. Le ho già detto che cosa farei io nei suoi panni”
Discorsi di questo genere il dottore ne faceva ogni giorno a Giuseppe Corte. Venne infine il momento in cui il malato, stanco di patire per l’eczema, nonostante l’istintiva riluttanza a scendere, decise di seguire il consiglio del medico e si trasferì al piano di sotto. Notò subito al terzo piano che nel reparto ‘regnava una speciale gaiezza’, sia nel medico, sia nelle infermiere, sebbene laggiù fossero in cura ammalati molto preoccupanti. Si accorse anzi che di giorno in giorno questa gaiezza andava aumentando: incuriosito, dopo che ebbe preso un po’ di confidenza con l’infermiera, domandò come mai fossero tutti così allegri.
“Ah, non lo sa?” rispose l’infermiera “fra tre giorni andiamo in vacanza”
“Come andiamo in vacanza?”
“Ma sì. Per quindici giorni, il terzo piano si chiude e il personale se ne va a spasso. Il riposo tocca a turno ai vari piani”
“E i malati? come fate?”
“Siccome ce n’è relativamente pochi, di due piani se ne fa uno solo..”
“Come? riunite gli ammalati del terzo e del quarto?”
“No, no” corresse l’infermiera “del terzo e del secondo. Quelli che sono qui dovranno discendere da basso” “Discendere al secondo?” fece Giuseppe Corte, pallido come un morto. “lo dovrei cosi scendere al secondo?” “Ma certo. E che cosa c’è di strano? Quando torniamo, fra quindici giorni, lei ritornerà in questa stanza. Non mi pare che ci sia da spaventarsi.”
Invece Giuseppe Corte – un misterioso istinto lo avvertiva – fu invaso da una crudele paura. Ma, visto che non poteva trattenere il personale dall’andare in vacanza, convinto che la nuova cura coi raggi più intensi gli facesse bene – l’eczema si era quasi completamente riassorbita – egli non osò muovere formale opposizione al nuovo trasferimento. Pretese però, incurante dei motteggi delle infermiere, che sulla porta della sua nuova stanza fosse attaccato un cartello con su scritto “Giuseppe Corte, del terzo piano, di passaggio”. Una cosa simile non trovava precedenti nella storia del sanatorio, ma i medici non si opposero, pensando che in un temperamento nervoso quale il Corte anche una piccola contrarietà potesse provocare una grave scossa. Si trattava in fondo di aspettare quindici giorni non uno di più, non uno di meno. Giuseppe Corte si mise a contarli con avidità ostinata, restando per delle ore intere immobile sul letto, con gli occhi fissi sui mobili, che al secondo piano non erano più così moderni e gai come nei reparti superiori, ma assumevano dimensioni più grandi e linee più solenni e severe. E di tanto in tanto aguzzava le orecchie poiché gli pareva di udire dal piano di sotto, il piano dei moribondi, il reparto dei “condannati”, vaghi rantoli di agonie. Tutto questo naturalmente contribuiva a scoraggiarlo. E la minore serenità sembrava aiutare la malattia, la febbre tendeva a salire, la debolezza generale si faceva più fonda. Dalla finestra – si era oramai in piena estate e i vetri si tenevano quasi sempre aperti – non si scorgevano più i tetti e neppure le case della città, ma soltanto la muraglia verde degli alberi che circondavano l’ospedale. Dopo sette giorni, un pomeriggio verso le due, entrarono improvvisamente il capo-infermiere e tre infermieri, che spingevano un lettuccio a rotelle.
“Siamo pronti per il trasloco?” domandò in tono di bonaria celia il capo-infermiere.
“Che trasloco?” domandò con voce stentata Giuseppe Corte “che altri scherzi sono questi? Non tornano fra sette giorni quelli del terzo piano?”
“Che terzo piano?” disse il capo-infermiere come se non capisse “io ho avuto l’ordine di condurla al primo, guardi qua.” e fece vedere un modulo stampato per il passaggio al piano inferiore firmato nientemeno che dallo stesso professore Dati.
Il terrore, la rabbia infernale di Giuseppe Corte esplosero allora in lunghe irose grida che si ripercossero per tutto il reparto. “Adagio, adagio per carità”, supplicarono gli infermieri “ci sono dei malati che non stanno bene”. Ma ci voleva altro per calmarlo. Finalmente accorse il medico che dirigeva il reparto, una persona gentilissima e molto educata. Si informò, guardò il modulo, si fece spiegare dal Corte. Poi si rivolse incollerito al capo-infermiere, dichiarando che c’era stato uno sbaglio, lui non aveva dato alcuna disposizione del genere, da qualche tempo c’era un’insopportabile confusione, lui veniva tenuto all’oscuro d tutto… Infine, detto il fatto suo al dipendente, si rivolse, in tono cortese, al malato, scusandosi profondamente. “Purtroppo però” aggiunse il medico “purtroppo il professor Dati proprio un’ora fa è partito, per una breve licenza, non tornerà che fra due giorni. Sono assolutamente desolato, ma i suoi ordini non possono essere trasgrediti. Sarà lui il primo a rammaricarsene, glielo garantisco… un errore simile! Non capisco come possa essere accaduto!” Ormai un pietoso tremito aveva preso a scuotere Giuseppe Corte. La capacità di dominarsi gli era completamente sfuggita. Il terrore l’aveva sopraffatto come un bambino. I suoi singhiozzi risuonavano lenti e disperati per la stanza. Giunse così, per quell’esecrabile errore, all’ultima stazione. Nel reparto dei moribondi lui, che in fondo, per la gravità del male, a giudizio anche dei medici più severi, aveva il diritto di essere assegnato al sesto, se non al settimo piano! La situazione era talmente grottesca che in certi istanti Giuseppe Corte sentiva quasi la voglia di sghignazzare senza ritegno. Disteso nel letto, mentre il caldo pomeriggio dell’estate passava lentamente sulla grande città, egli guardava il verde degli alberi attraverso la finestra con l’impressione di esser giunto in un mondo irreale, fatto di assurde pareti a piastrelle sterilizzate, di gelidi androni mortuari, di bianche figure umane vuote di anima. Gli venne persino in mente che anche gli alberi che gli sembrava di scorgere attraverso la finestra non fossero veri; finì anzi per convincersene, notando che le foglie non si muovevano affatto. Questa idea lo agitò talmente, che il Corte chiamò col campanello l’infermiera e si fece porgere gli occhiali da miope, che in letto non adoperava; solo allora riuscì a tranquillizzarsi un poco: con l’aiuto delle lenti poté assicurarsi che erano proprio alberi veri e che le foglie, sia pur leggermente, ogni tanto erano mosse dal vento. Uscita che fu l’infermiera, passò un quarto d’ora di completo silenzio. Sei piani, sei terribili muraglie, sia pure per un errore formale, sovrastavano adesso Giuseppe Corte con implacabile peso. In quanti anni, sì, bisognava pensare proprio ad anni, in quanti anni egli sarebbe riuscito a risalire fino all’orlo di quel precipizio? Ma come mai la stanza si faceva improvvisamente così buia? Era pur sempre pomeriggio pieno. Con uno sforzo supremo Giuseppe Corte, che si sentiva paralizzato da uno strano torpore, guardò l’orologio, sul comodino, di fianco al letto. Erano le tre e mezzo. Voltò il capo dall’altra parte, e vide che le persiane scorrevoli, obbedienti a un misterioso comando, scendevano lentamente, chiudendo il passo alla luce.